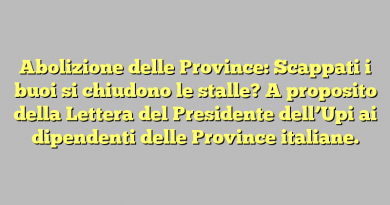Il diritto all’insorgenza
1.“L’Italia – recita il primo articolo della Costituzione – è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”[1]. In effetti, affidare ad un simile formula il valore fondativo di uno Stato non è un esito scontato, se pensiamo che una carta costituzionale altrettanto progressista, e frutto di un momento rivoluzionario antifascista, come quella dell’attuale Stato portoghese, non ha nel lavoro, bensì nella “dignità della persona umana” il suo fondamento[2]. Del resto, qualunque costituzione di una sovranità statale è direttamente legata al periodo storico in cui nasce ed è esito delle mediazioni e dei conflitti che ne hanno attraversato l’epoca di incubazione. Tuttavia, soprattutto nelle parti che definiscono l’orizzonte dei valori in cui pretende di collocarsi, una carta costituzionale non è rivolta all’indietro: “Principi generali” e “preamboli” vari costituiscono anzi l’esito di un compromesso proiettato sul futuro. Nella pratica di elaborazione delle carte costituzionali, sin dall’89 francese, i principi fondamentali – nel caso italiano, gli articoli 1-12 – costituiscono cioè una sorta di prospettiva aperta sul futuro di quello spazio di cittadinanza. Si potrà essere compiutamente cittadini di un certo spazio pubblico proprio in quanto si condividerà un certo orizzonte di valori, e dunque un certo orientamento delle condotte pratiche di vita, che il legislatore è sempre chiamato a tenere in considerazione. In questo senso possiamo dire che per i padri costituenti italiani lo spazio di cittadinanza della Repubblica figlia della Resistenza, lo spazio pubblico da essa inaugurato, coincide, o doveva tendere a coincidere, con la possibilità di espressione politica dei lavoratori: si è cittadini, si può essere cittadini, in quanto si è lavoratori[3].
È naturalmente in gioco, in questo caso, un principio di reciprocità: se il carattere fondamentale dello Stato è dato dalla coincidenza tra cittadino e lavoratore, esso può perpetuare la propria legittimità solo a condizione di garantire l’attività lavorativa dei singoli e la loro realizzazione personale. Il “lavoro” condensa dunque qui i fondamenti di quella “forma di vita” storica che quella Carta vorrebbe inaugurare.
Come Guy Debord aveva d’altra parte lucidamente osservato, i principi di validità delle varie costituzioni democratiche sono stati sottoposti, nei decenni del dopoguerra, ad una sistematica opera di svuotamento, prima tecnico-giuridica e, infine, anche simbolica[4]. Ma come avviene la delegittimazione delle funzioni istituzionali, o, forse, come ormai sembra chiaro, il lungo processo attraverso cui una forma istituzionale si trasforma, se non attraverso la sua destituzione, in larga misura imprevedibile e talvolta fortunosa, come Foucault ha insegnato, mediante modelli di condotte e “tecnologie” in grado, col tempo, – ed è questa invece lezione di Weber – di produrre nuove forme di valore?[5]
Altre pratiche, talvolta palesemente “incostituzionali”, hanno in effetti innervato negli ultimi anni lo statuto della cittadinanza italiana e anche qui il discorso di Debord è utile ad evidenziare come gli strumenti mediatici delle “società dello spettacolo” siano serviti a creare una sostanziale indistinzione tra i due orizzonti, sociologicamente separabili, della costituzione materiale e della costituzione percepita. Il principio etico-politico del diritto al lavoro ha potuto così essere svuotato e archiviato sotto gli orizzonti privatistici e appropriativi del diritto d’impresa, mentre lo Stato si è progressivamente ritratto, in linea con gli orientamenti neoliberistici invalsi in economia, da ogni ruolo formale di garanzia.
Sulle spoglie di un regime costituzionale, intendendo stavolta qui per “costituzione” non solo la “Carta” ma la “forma” generale dello Stato[6], può così aprirsi una battaglia senza quartiere, tra nuove pratiche, che definiscono ulteriori regimi di condotta e di valore, e nuove forme di dominio, che tentano a loro volta di imporre le loro gerarchie. La posta in gioco, oggi evidente, tra la traduzione costituzionale, e dunque vincolante per le stesse sovranità dei Paesi UE, dei trattati internazionali che implicano il rispetto del cosiddetto “fiscal compact”, la generale finanziarizzazione dei capitali e dei debiti sovrani, e l’estensione internazionale di movimenti locali che rivendicano una riappropriazione di spazi o anche semplicemente una visibilità pubblica del politico, non è niente di meno che la rivendicazione stessa di quell’orizzonte che è appartenuto fin qui alla sovranità statuale[7].
Ogni “costituzione” si configura infatti come un insieme di regole. Al di là di essa si apre però uno spazio anomico e an-archico in cui il politico rivela una natura priva di fondamento e nel quale le regole appaiono sospese come barchette su un mare in tempesta: e non è possibile avere in effetti troppi dubbi, ora, su chi intenda governare lo stato d’eccezione permanente determinato dalla crisi finanziaria[8]. Ma non tutto è scritto.
2.Se delle configurazioni di regole operano nelle istituzioni già costituite, ve ne sono però altre che operano in regimi costituenti, ancora informi: si tratta in entrambi i casi di “pratiche”, cristallizzate in un caso, inquiete e mobili nell’altro[9]. Ciò che è accaduto negli ultimi anni alla politeia italiana è allora, in realtà, esemplare del più ampio processo di trasformazione da cui sono state investite le democrazie occidentali: ma ciò che più conta è che l’orizzonte pubblico che essa garantiva è stato lacerato, forse irreversibilmente, attraverso forme di rivoluzione passiva che ne hanno minato la legittimità.
L’attacco al fondamento costituzionale del diritto al lavoro, come pratica di gestione del tempo di vita individuale e come formula caratterizzante la cittadinanza attiva, appare in questo senso dappertutto come la punta più avanzata di una eversione del diritto all’espressione pubblica della verità. Proprio attraverso la legittimazione etico-politica e l’istituzionalizzazione di pratiche che tendono a far coincidere tempo di vita e tempo di lavoro si sono prodotte nuove forme di potere capitalistico, caratterizzate da una progressiva atomizzazione sociale e dalla formazione di nuove forme di rendita, oltre che da quella struttura neo-tribale e neo-feudale della società riscontrabile ad esempio nella sospensione progressiva del diritto alla libera circolazione negli spazi urbani. Complice il miope laissez faire di molte amministrazioni comunali, e la produzione di adeguati stili di vita, abbiamo assistito in effetti, contemporaneamente al processo di volatilizzazione digitale dello spazio pubblico garantita dai network, ad una radicale metamorfosi nella pratica d’uso di piazze e di luoghi una volta “pubblici”[10]. Ancor di più, edifici ed intere zone delle città vengono lasciate all’incuria per poter poi cederle più facilmente, come accaduto a gran parte del patrimonio immobiliare, ferroviario e industriale dello Stato, a privati.
Un’esigenza di espressione priva di comunicabilità tenta delle mediazioni linguistiche innovative[11]: non è certo un caso quindi che il conflitto per la costituzione di nuove forme, anonime, di partecipazione politica e di ricreazione degli spazi pubblici abbia assunto negli ultimi anni l’aspetto di una vera e propria battaglia per la verità. Esperienze come Anonymus, Wikipedia e Wikileaks, o dei vari Occupy-, movimenti come i No-Ponte, No-Tav, No-Muos e No-copyright, per molti versi assimilabili alle antiche occupazioni cooperative dei “luoghi di lavoro”, fabbriche e terre, sono cresciute negli ultimi anni attraverso forme del tutto differenti, che potremmo pensare nei termini di veri e propri coaguli rizomatici[12]: i nodi intorno a cui le varie pratiche, rese di per sé pubbliche e insieme anarchiche dallo sviluppo delle reti sociali informatiche (Facebook innanzitutto), si coagulano, sono infatti caratterizzati dal transito di una qualche “testimonianza di verità” intorno alle nuove forme di asservimento che caratterizzano il presente. Il diffondersi delle proteste nel mondo arabo, tra 2011 e 2012, ha assunto presto la cifra di un vero e proprio movimento costituente o, come direbbe il filosofo francese Abensour, di una “democrazia insorgente”: ma anche lì è stata la testimonianza di una parola veritiera, scontata a volte con la vita, a coagulare su un “piano di consistenza” le rivendicazioni locali[13]. La testimonianza di verità, e la sua messa in comune, come pratica inquieta della democrazia, costituisce di fatto il nuovo incandescente crinale su cui si sviluppa l’orizzonte pubblico di questi anni e l’urgenza di una sua “occupazione”, come ancora nel caso del movimento di piazza Tahrir, in Egitto, o degli Indignados spagnoli. D’altra parte, se lo scotto da pagare alla “servitù volontaria” propria delle società spettacolari appariva a Debord come il capovolgimento del movimento dialettico hegeliano di vero e falso, l’emancipazione dalle sue spire, per quanto inedite, sembra coincidere oggi con l’urgenza di ristabilire altre gerarchia di verità: il falso deve tornare ad essere solo un momento del vero, ed è così che il carattere di “tumulto” delle nuove insorgenze sembra assumere sempre più uno statuto parresiastico[14].
“Un diritto che non è riconosciuto da nessuno non vale molto”[15] scriveva Simone Weil, e la distinzione che questa filosofa e socialista rivoluzionaria faceva tra lo statuto del diritto e lo statuto dell’obbligo coglie evidentemente un punto essenziale delle pratiche costituenti: un diritto è valido solo come introiezione di un obbligo da parte di chi è chiamato a riconoscerlo. Per meglio dire, l’estensione di un diritto, a qualunque livello, è possibile solo a partire da una proporzionale estensione della sua legittimità pubblica. Quando questa legittimità non è più garantita, quel determinato diritto viene meno, e solo la creazione di uno spazio pubblico in cui tale diritto appaia nuovamente sensato e seguito da obblighi corrispettivi può ripristinare delle condizioni politiche sottratte alla violenza del potere. “Ci si trova – scriveva infatti Weil mentre era prigioniera dei ritmi lavorativi della fabbrica Renault in cui aveva deciso di lavorare per qualche tempo – senza alcun soccorso, sotto i colpi di una forza del tutto sproporzionata rispetto a quella che si possiede, forza sulla quale nulla possiamo, e dalla quale rischiamo certamente di essere schiacciati – e quando, con l’amarezza in cuore, ci si rassegna a sottomettersi e a piegarsi, ci si fa disprezzare per mancanza di coraggio da quelli stessi che maneggiano quella forza”[16].
Redistribuire “tempo e ricchezza”: è questo uno dei motti del recente movimento che, nell’arco di pochi mesi, ha investito in Italia ben sei teatri[17]: abbiamo qui evidentemente la rivendicazione di una “gratuità” del tempo libero e di una sua radicale sottrazione alle forme di mediazione mercantile del diritto alla cultura. Attraverso esperienze di “autoproduzione” e “autoformazione”, unite ad una politica il più possibile assembleare, si elabora pertanto in tali iniziative la consapevolezza del legame intrinseco tra un’autonomia nella gestione del tempo di vita e un’autonomia nella gestione dello spazio pubblico. Il lavoro riprende qui il proprio ruolo costituente di forme di vita, in quanto pratica in comune e in quanto possibilità di uso comune, condiviso politicamente, del tempo di vita dei singoli: si tratta di qualcosa di un po’ diverso dalla semplice emancipazione dall’alienazione salariale, proprio in quanto non è solo il problema della “proprietà” a venir meno, ma è lo stesso modello appropriativo delle relazioni etico-economiche ad entrare in crisi. Appare chiaro oggi come non si possa più pensare di emanciparsi dall’asservimento individuale solo controllando l’esito del proprio lavoro, ma facendo invece di quell’esito – è lo stesso problema del sostentamento a porsi – il prodotto d’uso comune di una divisione del lavoro che sia innanzitutto una pratica in comune liberamente scelta.
Ed è la libertà, sovrana, di autodeterminazione della pratica di vita ciò che rende possibile emanciparsi dall’equivalenza invalsa tra “uso” e “proprietà”: in tal modo, il prodotto del “lavoro” non sarà tanto un bene comune – ed è qui la vera novità – bensì l’uso comune e libero del bene che si produce o si costituisce.
In questo senso, una certa pratica della democrazia appare legata indissolubilmente ad una diversa gestione di ciò che è “comune”.
3.Miguel Abensour individua nella “democrazia insorgente” la modalità con cui in Occidente si è dato quel carattere antitetico all’esercizio statale del potere che l’antropologia politica di Pierre Clastres, a sua volta permeata da letture di Nietzsche e La Boètie, aveva individuato in altri contesti: così, se “l’insorgenza è la forma viva della vera democrazia” ed è una “lotta continua per l’agire contro il fare”[18] essa assume di fondo il modello di quel potere costituente, che lega la lettura del politico da parte di Schmitt a quella di Arendt, così come a quella di uno storico dell’antica Grecia come Christian Meier. Il vero scopo che il filosofo francese persegue in queste pagine è però in realtà quello di rintracciare una dinamica costituente, un momento più propriamente “machiavelliano”, come lui lo definisce, all’interno del grande cantiere di Marx:
“[…] sembra che per Marx lo Stato politico sia in preda a una sovrasignificazione dovuta alla prospettiva, all’intenzionalità stessa che lo costituisce, come se fosse visitato dal fantasma di un orizzonte insospettato, situato al di là dello Stato”[19].
Ancora più chiaramente, appena qualche pagina dopo, Abensour scrive:
Dire che il centro di gravità dello Stato risiede fuori di esso vuol dire piuttosto che bisogna porre in rapporto lo Stato con questo movimento che lo eccede, che lo porta fuori dei cardini, con questa sovra-significazione che lo paralizza e il cui soggetto reale non è che la vita costituente del demos. Detto altrimenti, il popolo reale detiene il segreto della sovra-significazione che abita (hante) lo Stato moderno[20].
Il tentativo è naturalmente quello di inserire la storia del pensiero marxiano, e con esso la storia di una parte per nulla indifferente del movimento operaio del XX secolo, all’interno della storia più ampia della conflittualità moderna e in particolar modo di quella tradizione del conflitto riconosciuta a partire dal “repubblicanesimo” di Machiavelli e già a suo tempo ripensata da Rancière[21]. I due veri attori del conflitto sarebbero in questo caso, nella modernità, lo Stato e il carattere appunto insorgente della democrazia: la mediazione costituzionale della “democrazia rappresentativa” costituisce in questa prospettiva solo un elemento di legittimazione della forma statuale, laddove ogni altra forma di legittimazione era divenuta impossibile.
Ricorrendo a un vocabolario rousseauviano la democrazia insorgente si può definire come il sorgere del corpo del popolo contro il corpo dello Stato; in altri termini, essa è la manifestazione del Rapporto politico, che procede dal soggetto reale, il “demos totale”. È bene precisare, discostandosi da Marx e da questo termine, e preferendo quello di tous uns (oi polloi), che il corpo del popolo non dev’essere concepito come un organismo sostanziale, ripiegato su se stesso, ma come un corpo diviso, solcato da scissioni (clivé), proteso alla ricerca interminabile di una identità problematica. In effetti, la comunità politica si costituisce nell’esperienza di conflitti multipli, con l’intenzione di trasmettere ad ogni ambito – grazie alla riduzione – l’universalità democratica; e cioè un’esperienza della libertà che si configura come rifiuto del dominio, come non-dominio[22].
Possiamo così dire, seguendo Abensour, che allo statuto insorgente della democrazia, nella sua eccedenza an-archica, priva di fondamento in quanto ancorata alla molteplicità di forze politiche che investono il presente storico, viene rivendicato un carattere costituente ma anche de-costituente: i “conflitti multipli” in cui risiede la sua esperienza attraversano la possibilità di forme istituzionali, senza che però tali forme possano esaurirli. Le istituzioni costituite vivono con essa un rapporto di ambivalenza: esse hanno bisogno di una legittimazione che in definitiva solo al “politico” che si esprime nei tumulti possono chiedere. Questo statuto costituente e insorgente, in quanto sempre mobile, della “democrazia” rimanda a quella pratica diretta e non mediata che, da punti di vista opposti, filosofi come Schmitt o Arendt riprendevano dalle esperienze consigliste che avevano animato gli inizi della tribolata vita della Repubblica di Weimar. Per Schmitt, alla fine degli anni ’20, il tema rousseauviano dell’assemblea, letto in contrapposizione alle strutture della democrazia rappresentativa, consentiva di definire l’orizzonte di legittimazione di una Führerrepublik: intenzione di Arendt sarà invece, nel bel mezzo delle occupazioni universitarie americane, quella di riaffermare l’esperienza assembleare come pratica diretta della democrazia, scrostando il “mito” dell’insorgenza americana contro il dominio inglese proprio allo scopo di sottolineare nella stessa storia degli USA quei tratti successivamente messi in ombra dalla istituzionalizzazione capitalistica della democrazia rappresentativa[23].
Ma proprio il “modello” assembleare doveva fare i conti, già in Rousseau, con la difficoltà della sua istituzionalizzazione all’interno dell’architettura statuale moderna. L’ideale della sovranità rousseauviana è quello di un popolo perennemente riunito in assemblea, ma se esso era già difficilmente praticabile nell’antica Roma – e sappiamo del resto quante difficoltà i demoioi ateniesi provenienti dal contado incontrassero per partecipare alle ekklesiai – tanto più esso diventava evidentemente impossibile lì dove la sovranità implicava l’esercizio centralizzato di un potere statale:
Rispondo ancora che è sempre un male riunire parecchie città in un solo Stato; e che, volendo fare questa unione, non ci si deve lusingare di evitarne gli inconvenienti naturali […][24].
Ben prima di Rousseau, La Boètie si era interrogato sull’essenza di questa discrasia: la coincidenza tra sovranità e potere del demos implicava, in ogni caso, per quest’ultimo, un assoggettamento dei singoli ad una “servitù volontaria”. Qualunque legittimazione dell’Unità statuale da parte delle molteplicità costituenti è per lui in questo senso, di per sé, una introiezione delle pratiche su cui l’istituzione si regge: ed è nel dare risposta a tali questioni, poste già da Machiavelli, che Hobbes aveva d’altra parte definito i tratti di quella antropologia essenzialmente ferina e anarchica a cui Rousseau si opponeva. Solo una violenza originaria del diritto naturale poteva generare per il filosofo inglese il corpo dell’immenso Leviatano, e in tal modo giustificarne l’esistenza.
4. La reciprocità che si instaura tra “pratica democratica” e pratica etico-economica di “gestione comune dei beni” assume l’aspetto di una vera e propria “forma di vita” emancipata dal dominio dell’istituzione statale. Perché essa si realizzi, il tempo di vita dedicato al lavoro non può più apparire lontano, espropriato, alieno alla propria stessa amministrazione: se è nella pratica del lavoro che un individuo forma, innanzitutto, la propria capacità di emancipazione, un’economia dei beni comuni implicherà che la libertà di questa stessa formazione sia garantita come ogni altro “bene comune”. Un superiore diritto può essere fatto valere nei confronti delle pratiche istituzionali vigenti, per abbatterle, ed è solo grazie al riconoscimento di tale superiore diritto che una istituzione può essere a sua volta rilegittimata.
Non è un caso che le rivendicazioni e le insorgenze di questi anni assumano un carattere locale. Quasi che solo un territorio delimitato, la “città”, espropriata dei propri spazi e del diritto dei cittadini alla gestione del tempo di vita, possa infine riconfigurarsi come “luogo comune”, come una vera “forma di vita”, tutt’al più federata con altre: è in essa che la stessa democrazia può divenire una pratica comune, grazie alla salvaguardia del tempo di vita dei singoli come “bene comune” fondamentale. Del resto, come ricordava Benjamin, la percezione del tempo che si diffonde in tutti i momenti rivoluzionari è quella di una sospensione della sua abituale contabilità: si inaugura come un tempo festivo, un tempo che potremmo chiamare senza debito[25]. E allora, se una economia del debito regge le mitologia dell’origine statale, così come quella del contratto di lavoro capitalistico, e permane nella struttura “debitoria” della delega, una economia dei “beni comuni” sembra dover assumere de facto i tratti di una democrazia diretta, sempre critica rispetto alla violenza incorporata in ogni regola istituzionale[26]. Come scriveva Derrida, a proposito della questione della violenza posta da Sorel e da Benjamin:
Lo Stato ha paura della violenza fondatrice, cioè capace di giustificare, di legittimare (begründen) o di trasformare delle relazioni di diritto (Rechtsverhältnisse), e dunque di presentarsi come avente diritto al diritto. Questa violenza appartiene quindi in anticipo all’ordine di un diritto da trasformare o da fondare, anche se essa può ferire il nostro senso di giustizia (Gerechtigkeitsgefühl). Solo questa violenza richiede e rende possibile una “critica della violenza” che determini quest’ultima come qualcosa di diverso dall’esercizio naturale della forza. Affinché una critica, cioè una valutazione interpretativa e significante della violenza, sia possibile, si deve innanzi tutto riconoscere un senso a una violenza che non è un accidente sopravvenuto dall’esterno al diritto. Ciò che minaccia il diritto appartiene già al diritto, al diritto del diritto, all’origine del diritto[27].
Questo “qualcosa” che minaccia l’istituzione statale dal proprio interno sembra visibile, nel caso italiano, proprio nel primo articolo della Costituzione: che la “repubblica democratica” sia “fondata sul lavoro” non può che suonare oggi come una minaccia per quanti si fanno portavoci di una politica che svuota il “lavoro” dei singoli del suo ruolo costituente, proprio in quanto tempo di vita reso comune. Ma cos’è questo diritto su cui ogni diritto è costretto a fondarsi se non il vincolo che pratiche differenti instaurano a partire dal riconoscimento, dotato di autonoma “forza di legge”, del proprio essere-in-comune? E non è stata forse la lotta di liberazione dal nazifascismo innanzitutto la creazione di vincoli politici tra questioni e motivazioni “private”[28]?
È infatti a partire dal comune riconoscimento di pratiche, da una legittimazione superiore a quella del diritto vigente, che si determina un nuovo diritto, come il “diritto all’occupazione” di un teatro da parte di una “democrazia insorgente”. Solo in nome di un vincolo superiore a quello del diritto statuale, e in virtù di quella violenza che può deporre un assetto istituzionale, può trovare legittimazione il gesto di rompere un lucchetto che precludeva ad una città i suoi spazi. Qualunque “bene comune”, persino quello della salute, si costituisce dunque necessariamente, e diversamente non può essere, in rapporto ad una pratica di “violenza costituente”: così, la parresia, la pratica di testimonianza pubblica della verità, che sempre più abbiamo visto rivelarsi come un dispositivo di riconoscimento di nuove pratiche costituenti, rivela la propria affinità con l’orizzonte, a sua volta an-archico, su cui si fonda il diritto.
Ora, se il “diritto” implica, in quanto insieme di regole di vita, la creazione di un mondo, Agamben ha rilevato come agli esordi del monachesimo francescano la questione della “regola di vita” abbia investito proprio il problema di una eccedenza non riportabile ad istituzione:
[…] regole e vita entrano qui in una zona di indifferenza, in cui, nel venir meno della stessa possibilità di distinguerle, esse lasciano apparire un terzo, che i francescani, pur senza riuscire a definirlo con precisione, chiameranno […] “uso”[29].
La “regola” diventava così per Francesco un dispositivo giuridico operatore di un “vuoto giuridico”, ovvero di una “sottrazione radicale della vita alla sfera del diritto”[30]. Ed è allora proprio in questa direzione che le “regole” etico-economiche di quella forma di vita che abbraccia, insieme, la democrazia insorgente e la pratica dei beni comuni, sembrano implicare un orizzonte costitutivamente critico, una “zona di indifferenza”, appunto sottratta alle liturgie del diritto. L’uso in comune – di uno spazio in cui un’orchestra può finalmente avere il suo pubblico, di un tempo di vita, di una verità pubblica, di una casa – diviene così il fondamento senza fondamento, la pratica paradossale attraverso cui qualunque “regola” costringe la vita ad esprimere la sua eccedenza.