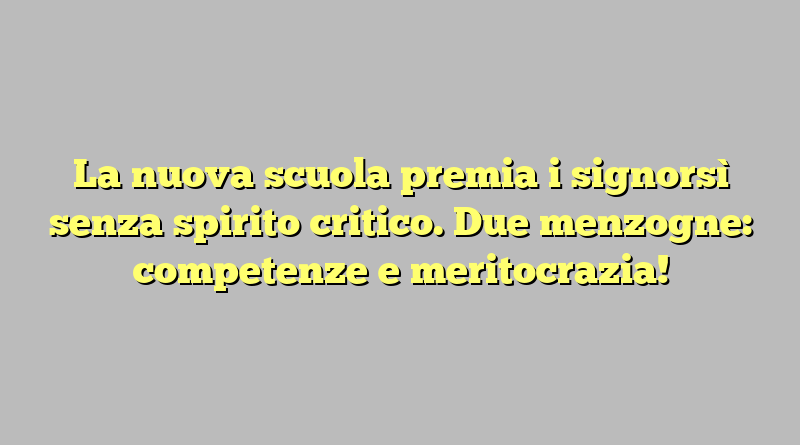La nuova scuola premia i signorsì senza spirito critico. Due menzogne: competenze e meritocrazia!
Quando si parla del mondo del lavoro e del mondo della scuola sembra sempre che si parli di due questioni totalmente distinte. E invece, nell’Italia con il Pil che crolla, nel mare magnum delle fugacissime questioni estive, ci sono un paio di notizie che si accoppiano per farci capire come dobbiamo immaginarci il futuro prossimo.
La prima è la disfida modello western tra Fiom e Fiat, simboleggiata al meglio dal duello in pieno sole tra Marchionne e Landini: il contenzioso nello specifico è la sentenza della Cassazione che obbligherebbe
La seconda è che il concorso per docenti che ha coinvolto milioni di persone in Italia sta volgendo al termine: entro l’estate ci saranno i vincitori.
Da una parte, anche qui, c’erano gli oppositori del concorso pensato ancora una volta una tantum, dall’altra – ex ministro Francesco Profumo in testa – coloro che hanno millantato questo concorso come l’inizio di un rinnovamento della scuola, con l’assoldamento di nuovi insegnanti 2.0 armati di tablet e di una cultura didattica à la page.
Ma cos’hanno in comune
Non si tratta di un restyling meramente linguistico, ma di un concetto che evoca un progetto di formazione abbastanza nuovo. La sua elaborazione compiuta per la scuola può essere datata al 2010 quando le Indicazioni Nazionali (che sarebbero il modo in cui sono stati riorganizzati i programmi scolastici) si sono adattate a una poco visibile rivoluzione teorica partita dagli anni Novanta che ripensava il mondo in cui viviamo alla luce di una fantomatica “società della conoscenza”.
Chi è stato a voler ripensare il mondo? Beh, parliamo soprattutto dell’Unione europea e altri organismi internazionali tipo l’Ocse, secondo i quali esiste un presupposto che dovremmo dare per scontato nell’educazione del futuro: se si migliora la qualità del servizio d’istruzione, si offrono ai cittadini le condizioni per “la costruzione di una vita realizzata” e per “il buon funzionamento della società”.
Il punto di partenza è stato il progetto DeSeCo (“Definition and Selection of Competencies”), da cui sono man mano scaturiti fior di documenti fino ad arrivare alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 2006, dove si definiscono quali sono le competenze di base che servirebbero in questa nuova società. Sono nello specifico otto: 1) comunicazione nella madrelingua, 2) comunicazione nelle lingue straniere, 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 4) competenza digitale, 5) imparare ad imparare, 6) competenze sociali e civiche, 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità, 8) consapevolezza ed espressione culturale.
Ecco qui, i requisiti che un bel cittadino europeo 2020 – per esempio i vostri figli, oppure voi (dato che siamo tutti coinvolti in processi di life-long learning come si dice) – dovrebbe possedere (Se ne volete sapere di più, la loro formulazione più precisa la potete trovare in libro-menhir, una specie di manuale di un nuovo ordine mondiale della “conoscenza” del 2003, edito da FrancoAngeli a firma di questi due grandi teorici delle competenze, D.S. Ryken e L.H. Salganik, che s'intitola Agire le competenze chiave. Scenari e strategie per il benessere consapevole. Sì, il titolo echeggia un po’ Scientology, ma che volete che sia). Prima di provare a capire cosa sono queste benedette competenze, possiamo già concordare a naso su una sensazione: la mancanza in questo microelenco di qualsiasi traccia di – come lo vogliamo chiamare? – sapere critico, né da un punto di vista della conoscenza, né da un punto di vista politico…
Il buon funzionamento della società non deve educare cittadini che mettano in crisi la società stessa? Questa potrebbe essere un’ingenua domanda. A cosa serve la scuola? A adattarsi al mondo così com’è, o a ripensarlo da capo a piedi?
E simili questioni se le pone un saggio illuminante di Edoardo Greblo – contenuto nel numero appena uscito (un numero monografico sulla scuola) di Aut aut – intitolato La fabbrica delle competenze. Per Greblo la conclusione è semplice: si educa alle competenze per avere lavoratori flessibili, adattabili a un mercato del lavoro sregolato e precario. Si educa l’individuo perché sia capace di sopravvivere nella giungla di un mercato feroce e deregolato, facendo di lui un possessore di competenze frammentarie e intercambiabili, più che una persona (come era pensato nella pedagogia deweyana che ha informato il Novecento e la nostra Costituzione, compromesso di cattolicesimo e socialismo).
Insomma pare che stiamo nel mezzo di una specie di trasformazione distopica inavvertita che passa per circolari e documenti nazionali per finire nelle aule scolastiche e nelle fabbriche e negli uffici. È proprio così? A dir la verità questa è la sensazione che si può avere, quando nell’universomondo di centinaia di libri di nuova didattica, uno si imbatte in un articolo semplice semplice di Marcel Crahay. Il suo Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la compétence en éducation può fare l’effetto dei documenti scritti da Emmanuel Goldstein in cui Winston Smith si imbatte a metà di 1984 di Orwell: ossia una sorta di disvelamento di tutto il progetto neo-sociale governato dal Grande Fratello.
È davvero così oscuro il futuro? Se non vogliamo concluderla con una cupissima evocazione fantascientifica, facciamo un passo indietro, senza schierarci subito dalla parte dei Savonarola. Interroghiamoci su cosa sono queste competenze, dicevamo. La verità è che rispondere non è per niente facile: sia Greblo che un altro ricchissimo saggio (uscito l’anno scorso per Carocci e passato in sordina), Insegnare concetti di Alberto Gaiani, mettono in luce che quando si parla di competenze non si capisce di che cavolo si sta parlando.
Non c’è una caratterizzazione di competenze che metta d’accordo gli studiosi: a partire dal lavoro di Ryken e Salganik, andando avanti e indietro si trova un grande minestrone teorico che butta insieme Vygotskij, Piaget e Bruner col pensiero debole e una spruzzata di sociologia di Bauman: una ridda di definizioni tale, tra documenti ufficiali e tentativi onnisintetici, da far scrivere a Marcel Crahay nel 2006: «La nozione di competenza è una caverna di Alì Baba concettuale nella quale si trovano accatastate, l’una accanto all’altra, tutte le correnti teoriche della psicologia, anche quelle più contrarie». Ma se è un concetto così confuso, se la parola “competenze” non è altro che quello che in sociolinguistica si chiama “plastismo”, ossia un concetto dal significato talmente vago da non averne alcuno, se insomma parlare di competenze è parlare di tutto e di niente, uno si chiede, queste competenze a cosa servono? E perché diventano così centrali nel riconsiderare la formazione per l’intero mondo occidentale?
Per due motivi, che Greblo mette in evidenza chiaramente. Primo, con le competenze si raggiunge l’obiettivo massimo di misurare con pretesa di oggettività qualcosa di immisurabile. Pare che si sia trovato lo strumento perfetto: ho dei numeri, un giudizio, una valutazione su qualcosa che in realtà vive nell’assoluto arbitrio. Tipo, mettiamo che vogliamo valerci di questa valutazione per competenze. Allora consideriamo come competenza quello che dicono Ryken e Salganik, ossia «il costrutto di cui abbiamo bisogno per fronteggiare la sfida della complessità, grazie al fatto che il tratto costitutivo e la riflessività, ovvero la capacità del soggetto di porsi nel mondo in modo flessibile, adattabile, tollerante, con apertura mentale, responsabile, con spirito d’iniziativa»: capite che non è difficile che se io sono quello che deve giudicare ho in mano un dispositivo talmente generico e plastico che me ne posso servire un po’ come voglio, no?
Secondo motivo – già evocato in quest’ultima definizione – le competenze sono il modo in cui impariamo a essere giudicati positivamente se siamo adattabili, se siamo flessibili, se c’integriamo bene nel mercato del lavoro, se detta alla spiccia non rompiamo il cazzo.
Dal momento che, per l’impresa, i servizi di formazione possono essere costosi, questa ha evidentemente tutto l’interesse a intervenire sulla scuola per spingerla a trasformare i propri programmi in termini di competenze… […] interpretare correttamente un problema, leggere correttamente una procedura, ritrovare in un testo di riferimento le informazioni utili per un certo uso, reagire in maniera critica a una situazione. Ne sono seguite forme di pressione sulle autorità dei sistemi educativi per intervenire sui programmi generali di studio e per introdurvi un apprendimento di queste specifiche competenze. (G.Le Boterf, De la competence: essai sur un attracteur etrange, Les Editions d'Organisation, Paris 1994).
Perché insomma le aziende si devono far carico di educare alla flessibilità se lo può fare la scuola? Perché non rendere il pensiero critico neutralizzato e strumentale ai bisogni di un’azienda? La verità è che ogni volta che s’invoca il feticcio della misurabilità oggettiva si occulta la più assoluta legittimazione della pura soggettività, dell’arbitrio. Come accade per le competenze, così accade per la “meritocrazia”: altro pseudoconcetto, altro plastismo che delle competenze è lo speculare; se io ho per le mani concetti così vaghi come competenza o merito, è chiaro che sarà fondamentale chi è che decide quali sono le persone competenti o quelle meritevoli.
Facciamo un esempio. Non è complicato valutare se uno conosce il pensiero filosofico di Leopardi e se sa fare l’analisi del testo della Ginestra. Mettiamo che io debba valutare e valutare se quello stesso studente a partire dalla conoscenza di Leopardi avrà sviluppato una serie di competenze. Per esempio? Per esempio «il possesso di una serie di risorse e la capacità di mobilitarle in un’azione complessa che coinvolge componenti cognitive e non cognitive», tenendo conto che «una competenza non può essere osservata o valutata direttamente, ma soltanto indirettamente, attraverso la performance prodotta dal singolo». Io docente valutatore, come mi barcamenerò? Che presunta oggettività utilizzerò? Valuterò positivamente la sua capacità di arrampicarsi sugli specchi? Valuterò positivamente la capacità che la lettura di Leopardi gli ha fornito di adattarsi a un ambiente lavorativo ostile?
Gli operai della Fiom hanno malinterpretato Leopardi e non utilizzato a dovere le competenze che la lettura della Ginestra, evitando di cooperare verso le magnifiche sorti e progressive evocate dal poeta? Mi ponevo questa domanda perché a un certo punto, dopo questa indigestione linguistica della retorica delle competenze, mi sono ricordato di un librettino, uscito da Einaudi vent’anni fa, Lo spirito Toyota di Taiichi Ohno. A risfogliarlo oggi si ha l’impressione di una profezia realizzata. Ci si ritrovano 'ste benedette competenze come un elemento già essenziale della “rivoluzione toyotista”: il ventaglio di competenze di un lavoratore deve essere talmente ampio da farlo sentire parte di un sistema produttivo globale.
Se non hai ancora cominciato, sviluppa competenze, se vuoi restare a galla nella fabbrica della “produzione snella”.
L’altro aspetto meno evidente, legato alla retorica delle competenze, è quello della delegittimazione della prospettiva etica e di quella politica nell’educazione.
Questo concetto [della prassi], nell’epoca della scienza e del suo ideale di certezza, ha perso la sua legittimità. Poiché da quando la scienza vede il suo scopo nell’analisi isolante dei fattori causali dell’accadere – nella natura e nella storia – riconosce la prassi solo più come applicazione della scienza […]. Così il concetto di tecnica ha sostituito quello di prassi; cioè la competenza degli esperti ha preso il posto della ragione politica» (H.-G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 2004 [ed. or. 1960], pp. XLV-XLVI; ma cfr., in generale, il cap. «L’attualità ermeneutica di Aristotele», pp. 363-376).
La storia della “didattica” nella nostra società occidentale forse parte proprio duemilatrecento anni fa, dal libro Alfa della Metafisica aristotelica in cui si dichiara esplicitamente che la conoscenza si definisce proprio per la sua possibilità di essere insegnata, e come tutto questo abbia a che fare chiaramente con una formazione politica: a cosa serve la scuola in fondo se non a farci capire come possiamo mettere in campo per cambiare il mondo in cui siamo capitati?
Per questo ogni volta che sento parlare di competenze mi viene in mente quanto per fortuna nelle parole di Aristotele, di Leopardi, di Nietzsche, di Freud, ecc… ossia di tutto quel canone che grazie al cielo resiste alle riforme scolastiche, di tutta questa neolingua non vi sia traccia. Espulso dal mondo del lavoro, della contrattazione sindacale, il pensiero critico; respinta come un fastidio la sentenza della Cassazione che dice di reintegrare in fabbrica gli operai Fiom; c’è solo da vigilare che questa liquidazione del linguaggio non allineato non riesca ad attecchire anche nella scuola, educando degli esseri umani adattabili, competenti, funzionali.
E certo sarebbe bello se, invece delle otto vaghe e inutili macrocompetenze indicate dall’Unione europea a qualcuno al Ministero dell’Istruzione venisse in mente di opporre l’endecalogo che Martha Nussbaum traccia in Non per profitto:
1. Esaminare una tesi. 2. Riflettere su essa. 3. Formularne una in modo autonomo. 4. Dibattere senza deferenze per tradizioni o autorità. 5. Riconoscere l’uguaglianza dei diritti. 6. Rispettare le persone. 7. Interessarsi agli altri. 8. Saper immaginare la complessità degli altri punti di vista. 9. Giudicare in modo critico chi detiene il potere politico. 10. Pensare a una nazione come un intero e non come una somma di gruppi. 11. Vedere la propria nazione in relazione alle altre.
Non è impossibile essere cittadini in un modo diverso, no?