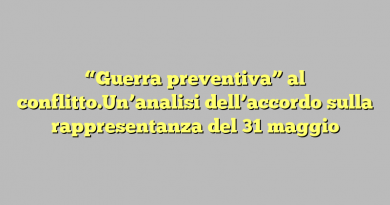A proposito delle due sinistre: dal big bang alla fusione fredda?
Mentre da più parti si auspica il superamento del paradigma delle “due sinistre”, Vendola apre alla possibilità che Sel confluisca nel Pd. Se prevalesse questa opzione la sinistra semplicemente si estinguerebbe, perché il Pd è un partito di centro completamente subalterno al mainstream della teoria economica. La sinistra può rinascere solo dal basso e dalle lotte
Qualche giorno fa, in questo stesso spazio, compariva un interessante articolo di Emilio Carnevali (“Oltre le due sinistre”) dedicato al dibattito sul superamento delle due sinistre aperto questa estateda Mario Tronti sull’Unità, cui è seguita una nutrita serie di contributi. Se rileggiamo il tutto alla luce dell’esito delle primarie del cd. centrosinistra, non si può non riscontrare alcune convergenze fra le analisi, le previsioni e la realtà. Se Tronti (di cui ben conosciamo la radicalità teorica e al contempo l’iperrealismo politico) si domandava retoricamente a luglio se avesse ancora senso una separatezza fra due sinistre «imprecise, provvisorie, incapaci di vera autonomia», Carnevali, con maggiore precisione, scrive che in caso di vittoria delle primarie da parte di Pierluigi Bersani con un esplicito appoggio di Nichi Vendola al secondo turno, il tema della ricomposizione della sinistra potrebbe tornare all'ordine del giorno.
A quel punto, secondo Carnevali, il leader di Sel «potrebbe decidere di trarne le conseguenze per giocare da dentro la sua partita, scegliendo di ‘rottamare’ una creatura politica esilissima – che non ha mai dato vera prova di vita autonoma – per entrare a far parte dell'ultimo ‘partito solido’ e radicato nel territorio rimasto in Italia». Non so se a Vendola sia capitato di leggere queste conclusioni, ma certamente ben si attagliano ad un passaggio chiave contenuto in una sua intervista a la Repubblica di lunedì 3 dicembre, ove il leader di Sel confida sulla «possibilità di aprire un cantiere in cui discutere del soggetto politico dei progressisti, del partito del futuro che non dovrebbe essere «un partito ideologico, ma un soggetto politico plurale in cui le diversità sono ricchezza». Un’intervista non ha il respiro di un saggio, ma certamente in poche ma chiare parole Nichi Vendola fornisce una lettura molta disinvolta delle finalità con cui Sel era nata. Nel documento votato dal congresso costitutivo di Firenze dell’ottobre del 2010, Sel si autodefiniva invece come «una forza autonoma nel progetto e nell’organizzazione» seppure aperta a politiche di alleanze, dal momento che l’operazione tentata con la formazione del Partito democratico era da ritenersi “fallita”.
Il quadro in due anni è certamente cambiato. Almeno apparentemente il Pd gode di piena salute e la vittoria di Bersani alle primarie ne ha probabilmente incrementato la forza e la capacità inclusiva. Il secondo turno delle primarie è diventato esplicitamente una gara interna al Pd, ma nel loro complesso tutte le primarie hanno visto il Pd come protagonista assoluto, soprattutto per la definizione del perimetro programmatico contenuto nella Carta di intenti, accettata con poche modifiche dagli altri partners, e per le regole ferree che la concludono e che dovranno guidare il comportamento parlamentare della coalizione.
Ma per capire se quel partito dei progressisti vagheggiato da Vendola e voluto da Bersani corrisponda al superamento in positivo della divisione delle due sinistre verso una loro ricomposizione in una sinistra più grande e attrattiva, bisogna fare qualche passo indietro e porsi qualche interrogativo sulla effettiva natura del Partito democratico.
Quando nel ’97 uscì una mia lunga conversazione con Fausto Bertinotti, raccolta nel volume Le due sinistre, la situazione era ben diversa, tanto in Italia quanto in Europa. In campo vi erano due sinistre ben distinte e, seppure di diverse dimensioni, entrambe dotate di vitalità e di potenzialità di sviluppo. I Gonzales, i Blair, i D’Alema si ponevano apertamente il problema di conquistare il centro del sistema politico e sociale per spianarsi la strada per il governo, mentre d’altro canto piccole forze comuniste sopravissute al cataclisma dell’89 portavano avanti significativi processi di rifondazione e nuovi movimenti alternativi e altermondialisti si apprestavano a diventare protagonisti della scena mondiale, almeno tra il ’99 e il 2003, addirittura la “seconda forza mondiale” dopo gli Usa secondo un famoso e enfatico articolo del New York Times.
Si verificavano anche importanti smagliature nel fronte della sinistra moderata. In Francia prendeva corpo l’alleanza fra i socialisti di Jospin e i comunisti su un programma estremamente avanzato che comprendeva la revisione del Trattato di Maastricht (tema del tutto scomparso come si vede anche dall’esperienza di Hollande che accetta il fiscal compact che quel trattato modifica in peggio) e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione. In Italia la distanza tra le due sinistre era ben sintetizzata persino dai titoli, oltre che dal contenuto, di due articoli pubblicati sulla stessa rivista, Critica Marxista, da Massimo D’Alema (Governare lo sviluppo) e da Fausto Bertinotti (Cambiare la società). Altri, come Marco Revelli di cui quasi contemporaneamente usciva Le due destre (Torino, 1996), dava un giudizio ben più severo – e forse preveggente – della sinistra moderata, l’allora Pds, considerato «più un’appendice della seconda destra (quella tecnocratica e elitaria n.d.r.) che non un soggetto politico autonomo».
Quella situazione oggi non esiste più, ma in senso diverso da quello tratteggiato da Tronti e ripreso da Carnevali. Non si può più parlare di due sinistre semplicemente perché quella moderata si è fatta centro, perdendo oltre che le connotazioni programmatiche, persino il nome di sinistra e l’altra, quella radicale, si è frammentata ed è rimasta come annichilita di fronte alle trasformazioni che pure aveva previsto e combattuto in una prima fase, come la stessa crisi economica mondiale manifestazione di quel processo di globalizzazione così acutamente analizzato sul finire dei Novanta.
Il Pds ha cambiato nome in Pd, cancellando l’ultima traccia di significante di sinistra (nomina substantia rerum sunt ammoniva Massimo Cacciari ai tempi della Bolognina); ha modellato posizioni e programmi secondo il mainstream nel fondamentale campo della teoria economica; ha inseguito ogni avventura bellica che potesse coinvolgere in qualche modo il nostro paese; ha accettato che una grave e sostanziale lesione della democrazia avvenisse tramite l’imposizione del governo Monti da parte delle elites politico-finanziarie europee; ha sostenuto con assoluta determinatezza tanto il pareggio di bilancio in Costituzione quanto il fiscal compact; ha persino definito la liquidazione dell’articolo 18 come un passo in avanti nel campo del diritto al lavoro. Tale quadro non è affatto contraddetto dalla carta di intenti dei progressisti e dei democratici (si noti che anche qui il termine sinistra scompare, pure se accompagnato pudicamente dal termine centro con o senza trattino).
Le posizioni di Stefano Fassina, che ben conosco, sono un conto, il testo della carta di intenti, firmato anche da Sel e dal Psi, tutto un altro. Lì si dice che il conflitto sociale non sta più nello scontro imprese (anche si sarebbe dovuto scrivere casomai “proprietà delle imprese”) e lavoratori, ma è interno alla complessità del mondo del lavoro. Affermazione fatta in contemporanea con la negazione delle assunzioni dei lavoratori targati Fiom nella nuova fabbrica di Pomigliano. Qui siamo fuori da qualunque tradizione socialdemocratica e laburista, che pur con tutto il moderatismo di cui sono state capaci, fondavano pur sempre la propria referenza sociale nel mondo del lavoro e di quello dipendente in particolare.
In questo nuovo quadro avrebbe dovuto e potuto trovare spazio la costruzione di una nuova sinistra, certamente basata sul superamento delle vecchie divisioni del novecento, come quelle tra socialisti e comunisti, tra riformisti e rivoluzionari, ma pur sempre fondata sulla rappresentanza del mondo del lavoro materiale e immateriale, dipendente e autonomo, stabilizzato e precario, per fare partire da qui una proposta di uscita dalla crisi senza operare quel massacro sociale insito nelle politiche di austerity condotte a livello europeo. Una sinistra dal forte carattere europeista, ma al contempo conscia della necessità di una modifica radicale dei trattati che attualmente regolano la vita della Ue, che sono la principale ragione del suo stato di crisi e di sofferenza delle sue popolazioni.
Una sinistra di questo genere non può costruirsi per ricomposizione tra il Pd e ciò che resta delle miniformazioni che si collocano alla sua sinistra, come auspicava Tronti e sembra ripetere nella intervista citata Vendola. Ma al contrario attraverso un processo duplice di scomposizione e di ricomposizione. Di ricomposizione della sinistra radicale che sia opera non tanto dei suoi micro ceti politici quanto soprattutto della sinistra diffusa, che è stata protagonista delle lotte più significative, alcune vincenti come i referendum sull’acqua e il nucleare (a questo allude il tentativo di “Cambiare si può”). Di scomposizione del Pd tra la sua anima dichiaratamente liberista, più cheliberal, e quella che potrebbe essere effettivamente iscritta in una moderata socialdemocrazia.
Un processo difficile senza dubbio. Ma che corrisponde alla gravità della crisi che stiamo attraversando, che per l’Europa ha conseguenze sociali peggiori di quella post ’29. Un processo che richiede elaborazioni teoriche ardite e non poco, basate non solo sul recupero del pensiero marxiano, ma anche su quello keynesiano che pure non era tenero nei confronti del primo; sulla grande innovazione rappresentata dal pensiero ecologista e della differenza di genere. Proprio qui sta il nocciolo della questione per una moderna sinistra che voglia continuare a pensare che il capitalismo nelle sue varie versioni non sia la fine della storia: come coniugare il principio dell’uguaglianza con quello della differenza, in altre parole come dare risposte non contraddittorie a bisogni sociali e a diritti. Che non sia pura astrazione lo dimostra la drammatica vicenda dell’Ilva di Taranto, per fare solo un esempio, ove lavoro e salute sono stati tra loro contrapposti.
Se invece prevarrà l’idea che l’attuale coalizione dei progressisti e dei democratici deve diventare, ben oltre l’alleanza elettorale, la costituente del nuovo partito, ove si riversano le componenti una volta radicali e nello stesso tempo si rafforza al suo interno quella liberista incarnata dalla considerevole affermazione nelle primarie di Matteo Renzi, se dalla teoria del big bang si scivolasse in quella della fusione fredda, non avremo più né due sinistre né una grande sinistra, ma nessuna. Almeno come forza politica organizzata dotata di una sufficiente massa critica per farsi riconoscere e pesare nell’azione.