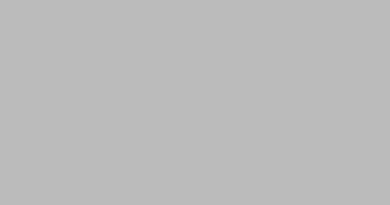Capitalismo europeo, nuova governance e movimenti sindacali
Quasi in conclusione di un libro dedicato all’analisi del sistema industriale tedesco – divenuto poi un classico della sociologia industriale e che quasi trenta anni fa aprì un dibattito tanto ampio quanto inusitato per la complessità e lo specialismo della materia (1) – Horst Kern e Michael Schumann, entrambi docenti all’Università di Gottinga, osservavano come:
“… la seducente prospettiva di una marcia indietro della divisione del lavoro non deve fare dimenticare i lati negativi di questo sviluppo. Essi risiedono nell’esclusione di una parte consistente della forza lavoro da questo rivolgimento e, ancor peggio, aggravano in parte l’isolamento di singoli gruppi. Anzitutto restano chiaramente ai margini i soggetti a rischio sul mercato del lavoro, la cui probabilità di rimanere rinchiusi nel ghetto della disoccupazione permanente diviene ancora più grande con le nuove concezioni della produzione (essenzialmente il postfordismo, N.d.R.). La manodopera dei settori in crisi, così come gli operai comuni marginalizzati nei settori centrali, non possono quantomeno aspettarsi nella di buono dalla trasformazione legata alle nuove concezioni produttive: le loro chances sul mercato del lavoro risultano piuttosto compromesse dall’innalzamento delle barriere d’ingresso alle aree fiorenti. La fine della divisione del lavoro all’interno del centro della produzione industriale coincide dunque con un tendenziale rafforzamento delle frontiere verso l’esterno. Per questo motivo parliamo della segmentazione come nuova variante della polarizzazione.”
Le analisi di Kern e Schumann
Gli stessi autori avevano già condotto, verso la fine degli anni ’60, uno studio poi raccolto in volume (2), nel quale avevano preso decisamente le distanze da chi dava per sicura una positiva correlazione fra progresso tecnico e umanizzazione del lavoro, come sosteneva ad esempio Robert Blauner, secondo cui il processo di automazione avrebbe addirittura eliminato il fenomeno dell’alienazione nel processo produttivo (3).
A quel tempo i “trent’anni gloriosi” dello sviluppo capitalistico, entro i quali cresceva anche il lavoro e la classe degli operai, si stavano oramai concludendo. I movimenti del ’68, che nel caso italiano avevano visto come originali protagonisti tanto gli studenti-massa, quanto gli operai-massa, ovvero quei lavoratori comuni di cui parlano Kern e Schumann, stavano scuotendo il mondo e in particolare il vecchio continente.
Agli inizi degli anni ’70 nella più grande nazione manifatturiera d’Europa, la Germania, si discuteva di “umanizzazione del lavoro”, includendo in questa voce un insieme di atti e di politiche teso a ridurre le conseguenze negative e disumanizzanti della parcellizzazione delle mansioni lavorative. Ma quindici anni dopo quel libro, i due docenti di Gottinga giungono a una conclusione sensibilmente diversa, cioè quella che “il management capitalistico può conseguire una maggiore efficienza solo allentando le regole della divisione del lavoro”. Ma questo tendenziale superamento della rigidità della parcellizzazione, questa fluidificazione delle mansioni e delle prestazioni lavorative nell’industria – che peraltro convivono nel sistema decentrato produttivo con le precedenti forme di organizzazione del lavoro, più rigidamente suddivise e gerarchizzate – non devono sfuggire a una nuova critica che, partendo proprio dal riconoscimento della modernizzazione avvenuta, ne indaghi le nuove forme di sfruttamento e di alienazione del lavoro operaio.
Superare i limiti privatistici del sistema produttivo
Kern e Schumann si pongono infatti il tema di “sottrarre le concezioni della produzione ai loro limiti privatistici”, pur in modo gradualistico, poiché queste accentuano il contrasto già analizzato da Marx e poi da Lenin nella sua analisi dell’imperialismo, fra il carattere sociale della produzione e quello privato dell’appropriazione dei profitti. Si propongono in primo luogo la critica di una modernizzazione che avviene sul terreno squisitamente economico ed è ispirata dai principi e dai criteri di quest’ultimo, indicando i seguenti, quali contro interventi urgenti da applicare:
- “sfruttamento espansivo della massa complessiva di funzioni qualificate, ampliatasi con la diffusione delle nuove tecnologie, per una definizione complessa dei posti di lavoro che interessi la quota più alta possibile di forza lavoro;
- utilizzo delle nuove tecnologie per eliminare le funzioni più elementari, nella misura in cui questo non comporti una distruzione di posti di lavoro
- orientamento dei processi di formazione verso un concetto esteso di qualificazione (nessuna delimitazione a capacità inerenti a processi specifici; orientamento verso un lavoro professionale sovrano; possibilità molteplici, sia professionali che nella sfera privata, delle e conoscenze e delle capacità);
- nessuna determinazione unilaterale delle esigenze relative al rendimento; obbligo di pervenire a un compromesso.”
Basta gettare uno sguardo alla condizione lavorativa presa nel suo insieme nel contesto europeo per accorgersi che nessuno di questi punti, ritenuti dagli studiosi decisivi per offrire un governo “politico” alla modernizzazione, si è realizzato. Non solo ma l’esplodere della attuale crisi e le politiche concretamente innestate dalle elites europee, hanno fatto retrocedere molti di questi aspetti a una condizione peggiore di come si trovavano alla fine degli anni ’70.
Le responsabilità del neoliberismo e del social-liberismo
Le responsabilità principali stanno indubbiamente nel trionfo delle dottrine neoliberiste sopravvenute dagli anni ’80 in poi, fino ai nostri giorni, malgrado che la più grande crisi economica del capitalismo europeo attualmente in pieno svolgimento le revochi fortemente in dubbio su molti versanti. Ma sarebbe troppo comodo fermarsi a questo.
Altrettanto grave è la responsabilità di quello che alcuni studiosi, come Riccardo Bellofiore, hanno chiamato social-liberismo, che è ormai divenuto un termine sempre più diffuso e condiviso da economisti e sociologi a livello internazionale. In altre e più dirette parole chi per tanti anni ha rappresentato la sinistra nel continente europeo ha abbracciato da tempo, con l’aggravante della foga dei neofiti, le teorie del primato delle ragioni di mercato sui diritti e la politica.
Questo ha naturalmente influito negativamente sull’insieme del movimento sindacale, che pure ha colpe proprie per avere abbandonato due terreni tipici del suo agire, quello della rivendicazione salariale (dagli anni ’80 in poi la curva della distribuzione della ricchezza fra salari e profitti è si è mossa solo in questa ultima direzione), gettando alle ortiche la sua “autorità” in questo campo (sintomatica anche l’ultima conferenza programmatica tenuta a gennaio 2012 dalla Cgil, dove il tema del salario era praticamente assente), e quello della contrattazione sulle modalità della prestazione lavorativa e dell’organizzazione del lavoro.
Nel contempo anche l’esperienza della partecipazione dei lavoratori all’impresa, soprattutto per quanto riguarda la loro possibilità di influire sugli indirizzi e le scelte produttive, – che, con il piano Meidner in Svezia giungeva addirittura sulla soglia della messa in discussione degli assetti proprietari delle aziende, mentre con la Mitbestimmung tedesca trovava una codificazione normativa durevole nel tempo – sembra avere esaurito la sua spinta propulsiva e conosce, in contemporanea con l’aggravarsi della crisi economica, forme di svuotamento e di burocratizzazione.
Né può chiamarsi fuori da questo concerto di responsabilità negative neppure la sinistra d’alternativa, in special modo in quelle sue componenti che hanno teorizzato la sostanziale marginalizzazione o inessenzialità del lavoro organizzato in imprese e aziende, quale molla trasformativa degli assetti sociali complessivi, sostituendo a questo indistinte moltitudini.
Le premesse per la rinascita di un movimento sindacale europeo
La tesi che quindi qui si vuole affermare è che la rinascita di un movimento sindacale europeo non sta solo nella capacità di riorganizzarsi a seguito dei processi di frammentazione della forza lavoro da un lato e dall’altro di concentrazione senza centralizzazione delle imprese su scala internazionale ( o, per dirla con Francesco Garibaldo, di contemporanea “verticalizzazione” e “decentralizzazione”)(4). Né che essa possa solo essere affidata all’assunzione più decisa di pratiche di lotta transnazionali a fronte della evidente internazionalizzazione delle imprese, non più solo quelle di grandi dimensioni, o della crisi e del mutamento di ruolo degli stati nazionali che sottrae al sindacato un interlocutore politico e istituzionale un tempo autorevole e a portata di mano.
Non si tratta solo di questo, per quanto sarebbe già di per sé moltissimo. Il problema che a questo si arriva solo se si riparte dalla critica della condizione strutturale degli apparati produttivi diffusi su scala globale e dalla convinzione che il lavoro resti una leva fondamentale per un’azione trasformativa della società e del risanamento dell’ambiente, per quanto esso ci appaia frammentato, diviso e contrapposto al suo stesso interno, precarizzato, privato di confini sensibili fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, polarizzato nelle sue condizioni normative, funzionali e retributive, non più iscrivibile nelle tradizionali e securizzanti distinzioni tra lavoro intellettuale e manuale, autonomo e dipendente, creativo e ripetitivo. Insomma non rinasce una nuova coalizione del lavoro, al di là della discussione necessaria sulle nuove forme organizzate che questa deve assumere, se in primo luogo non torna ad essere senso comune che le categorie di sfruttamento, relativo e assoluto, e di alienazione sono ben vive e universalmente operanti e si riproducono con virulenza nelle esperienze dei capitalismi emergenti, a partire da quello già molto sperimentato della Cina.
La contraddizione fra nuovo capitalismo e democrazia
Se vogliamo guardare la stessa cosa, ma da un altro punto di vista, risulta subito evidente che siamo di fronte ad una stridente contraddizione fra capitalismo e democrazia, allo svuotamento di senso e di funzione delle istituzioni tradizionali della democrazia delegata, alla ghettizzazione delle forme di democrazia diretta, allo stabilirsi di una governance europea che riduce il potere e l’autonomia delle singole sovranità nazionali, sostituendole con una sovrastruttura internazionale completamente a-democratica, quindi strutturalmente e intimamente impermeabile alle istanze sociali. Ma anche e proprio per tutte queste ragioni il sistema industriale e produttivo allargato, in quanto supporto decisivo della riproduzione materiale, rimane un centro di potere determinante della società.
Il fatto che questo centro di potere tenda ad autonomizzarsi o meglio ad assumere un ruolo preminente nel rapporto con gli stati nazione, al punto da determinarne gli indirizzi politici, le condizioni normative, le scelte operative, soprattutto in campo finanziario, quindi ad assumere direttamente un sistema di regole e di governance che travalicano e sopravanzano le legislazioni preesistenti, finendo per modificarle anche formalmente, come è evidente nel rapporto di Fiat con il nostro paese, non fa altro che esaltare questo ruolo di centro di potere posizionandolo a livello sovrannazionale.
La massiccia finanziarizzazione del capitale – tratto caratteristico dell’attuale globalizzazione – non elimina questo ruolo, casomai lo rende più opaco e impenetrabile. Così come quel processo, già previsto da Marx in un famoso passo del terzo libro del capitale (5) e sviluppatosi prepotentemente in tempi recenti, di separazione della proprietà giuridica e di fatto dell’impresa dal suo controllo e dal suo management, rende impersonale di fronte al lavoratore la stessa figura del padrone, aumentando proprio per questo l’autorevolezza della proprietà in quanto istituzione data e generale.
Se negli anni ’60 e nei primi ’70, non solo nel contesto italiano, l’essere autorità salariale e la capacità al contempo di intervenire sui temi dell’organizzazione del lavoro, della prestazione lavorativa e dei diritti della persona che lavora conferiva al sindacato stesso in modo quasi naturale e conseguente un ruolo di attore politico nella società nel suo complesso, trasformandolo in un interlocutore indispensabile degli stessi governi, sia che fosse in ragione della potenza di conflitto esercitabile che, in altre condizioni, del ruolo di partecipazione nelle imprese che gli conferiva potere, l’inverso non poteva avvenire e infatti non è avvenuto.
Il declino del ruolo politico del sindacato
Anzi è accaduto il suo opposto. L’avere privilegiato un ruolo politico non conflittuale, ovvero la concertazione, ha prima mortificato la funzione contrattuale, poi l’ha curvata direttamente alle proprie esigenze, fino a giungere, nel caso italiano, alle evidenti mosse per via pattizia o legislativa di immiserimento se non cancellazione del ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il presunto privilegio della contrattazione di “prossimità”, aziendale o di territorio, non ha significato affatto una maggiore sensibilità alle tematiche della condizione lavorativa sui luoghi di lavoro e quindi a una ripresa di efficacia su questi temi, poiché a questo cosiddetto secondo livello è riservata una parzialissima e moderata ridistribuzione della ricchezza prodotta in ragione del tasso di produttività specifico, per sostituire la cassata funzione di aumento e recupero salariale un tempo propria del contratto nazionale.
Naturalmente a facilitare questo approdo, ha concorso in modo certamente decisivo, ma non inevitabile, la nuova condizione in cui si esplica la competizione nella attuale fase della globalizzazione, che, come ben sappiamo è contraddistinta da una gigantesca crisi economica, che è anche crisi della globalizzazione così come l’avevamo conosciuta fino alla metà della prima decade del duemila. La famosa frase di Marchionne sul fatto che l’impresa nel suo complesso, inclusiva del lavoro, è chiamata a una guerra di sopravvivenza con e contro altre sullo scenario mondiale, esemplifica questa nuova condizione. Questa sostanzialmente si svolge, da un lato, accentuando il peggioramento delle condizioni retributive e lavorative – che già erano un tratto caratterizzante della globalizzazione guidata dalle teorie neoliberiste dagli anni ’80 in poi – al fine di incrementare la capacità competitiva sul mercato mondiale, cercando quindi di impostare strategie di politica industriale basate sull’esportazione. Il che ovviamente non può avvenire per tutti, ma solo per i paesi industrialmente e finanziarmente più forti, capaci di piegare le relazioni normative, economiche e commerciali a proprio vantaggio, come è il caso esemplare della Germania nel contesto della Ue.
Dall’altro lato, questo sistema competitivo così aggressivo necessita, per chi lo conduce, di avere il pieno controllo di tutti i fattori della produzione. In altre parole la concentrazione senza centralizzazione richiede per funzionare un potente controllo, praticamente una militarizzazione di tutti i fattori produttivi, a cominciare dal lavoro umano. E’ evidente che in questa strategia il sindacato, se ad essa non si ribella fin dall’inizio, è destinato ad essere tenuto fuori dall’impresa (vedi caso Fiat, ove persino quando i lavoratori sono reintegrati su sentenza della magistratura ottengono il salario ma non il loro lavoro) o ad essere praticamente inglobato nel governo allargato della medesima seppure in funzione subordinata e senza le condizioni di formalizzazione che almeno nella Mitbestimmung tedesca gli conferiscono alcuni diritti e poteri. Nelle imprese si manifesta quindi una sorta di “stato di eccezione”, per usare un termine tornato in voga con Giorgio Agamben (6) seppure da questi riferito alle istituzioni statuali, in cui ogni forma di democrazia sindacale e nelle relazioni industriali, qualora esistente, viene del tutto sospesa o addirittura stabilmente cancellata. L’impresa funziona così come un centro di potere che irradia di sé l’intera società e impone l’egemonia dei suoi “valori”: basti pensare, per fare un solo esempio, all’estensione in ogni angolo del vivere sociale del concetto di competitività. Infatti se non si accetta il principio della irriducibilità del contrasto fra capitale e lavoro (il che non significa necessariamente che l’uno debba e possa avere il definitivo sopravvento sull’altro), che invece nella pratica è dimostrato dalla sua continua riproducibilità in ogni angolo del pianeta, ovvero si nega il carattere duale nell’impresa, si spalanca le porte a una concezione totalitaria della democrazia che finisce per permeare l’intera società. In questo modo non è solo la democrazia sindacale a venire meno, ma la democrazia tout court.
L’involuzione del diritto del lavoro
Diventa importante a questo punto svolgere qualche considerazione sull’evoluzione del diritto del lavoro. Nel sistema capitalistico il nesso tra le sue frequentissime crisi e i cambiamenti del diritto del lavoro è alquanto stretto. Secondo Carlos Palomeque, dell’Università di Salamanca, si può addirittura dire che la crisi è una “compagna di viaggio” storica del diritto del lavoro (7).
Se il nostro pensiero corre subito alla controriforma attuata dalla Fornero, tra cui l’abrogazione dell’articolo 18, non è tuttavia storicamente vero che tale relazione comporti sempre un fatto negativo e recessivo per il diritto al lavoro. Non avvenne così nel New Deal americano o ai tempi della repubblica di Weimar, due situazioni storiche dagli opposti esiti, quando, soprattutto nel secondo caso, il diritto del lavoro fece importanti passi in avanti in direzione democratica.
In Europa il diritto del lavoro conosce il suo sviluppo maggiore in seguito alla caduta delle dittature e delle ideologie fasciste, come risultato fra il confronto e lo scontro del liberalismo economico anglosassone e il pensiero socialista e comunista. La necessità di fronteggiare la simpatia popolare verso il comunismo sovietico fece il resto. Così che si può convenire con Umberto Romagnoli quando sostiene che il diritto del lavoro è fortemente “eurocentrico, il più eurocentrico dei diritti” (8). Quel diritto si è sviluppato e rafforzato su una base sostanzialmente nazionale-statale, in un quadro dove rilevante è stato l’intervento pubblico diretto nella economia che ha favorito momenti avanzati di accordi che hanno in diversi casi funzionato da traino per una legislazione innovativa. La crescita e l’implementazione del diritto del lavoro è stato uno dei pilastri su cui si è costruito e modellato il “modello sociale europeo”.
Come sappiamo, a partire da Lord Beveridge, la realizzazione dello stato sociale comporta l’obiettivo della piena occupazione. Questo non solo per evidenti ragioni di sostenibilità finanziaria del primo, ma perché in questo modo si stabilisce un circuito particolare fra lavoro e consumo. Infatti è implicita nella concezione e nella realtà dello stato sociale, quando esso è pienamente funzionante, la “demercantilizzazione” dei bisogni primari, che infatti diventano diritti concretamente fruibili, nel senso proprio che il soddisfacimento degli stessi non dipende più dal potere d’acquisto dei singoli, né la fruizione dei servizi che soddisfano tali bisogni può essere regolata dal rapporto fra domanda e offerta, e quindi da prezzi stabiliti dal mercato.
In questo quadro anche quella particolarissima forma di merce, che è la forza lavoro, tende a demercantilizzarsi, poiché si riconosce ad essa, grazie alle conquiste sindacali e democratiche, lo status di portatrice di diritti collegati alla persona umana che non sono mercanteggiabili. E’ su questa base che prende forma nelle Costituzioni più avanzate, quale la nostra, il principio dell’equa retribuzione che deve essere indipendente tanto dalle regole della domanda e dell’offerta sul mercato del lavoro, quanto dalla quantità di tempo dedicato alla prestazione lavorativa. Proprio per questo il lavoro è stato fonte di una fertile ambiguità. Da un lato il rapporto di lavoro, in particolare modo quando è subordinato, comporta la condizione di soggezione e sfruttamento per i lavoratori stessi, che tende ad estendersi a tutto l’ambito sociale, Dall’altro esse ha rappresentato la molla per sviluppare titolarità e esercizio dei diritti sociali, ovvero ha funzionato da fondamento della cittadinanza sociale, cosa ben diversa da quella formale.
La globalizzazione, la nuova governance di cui si è venuta dotando la Ue e naturalmente la crisi economica, hanno fatto saltare questi nessi. Affermare oggi che il lavoro è fondamento della cittadinanza sociale è una frase praticamente vuota di senso, poiché esso è scarso, a causa delle ristrutturazioni e delle strategie labour serving, e quando c’è è talmente privo di diritti e poteri da essere piuttosto un esempio negativo per il sociale. Allo stesso modo la cittadinanza sociale è colpita profondamente dallo smantellamento e dalla privatizzazione delle istituzioni del welfare. Quindi prescindere dalla democratizzazione del mondo del lavoro e dalla modificazione dei rapporti di potere reali al suo interno, significa mutilare il diritto di cittadinanza di un suo punto essenziale. Per queste ragioni – sia detto qui per inciso e solo di sfuggita, essendo il dibattito su questo tema vastissimo quanto controverso – mi pare sbagliato separare totalmente l’istituzione di un reddito sociale (o di cittadinanza che dir si voglia) dalla ricerca di un lavoro, non di un’occupazione qualunque e dannata, ma di undecent work, come dicono gli anglosassoni.
La decostruzione europea
Difficile, quindi, non convenire con Alain Supiot, quando affermava in occasione di un convegno di studi promosso in memoria di Bruno Trentin (9) che “siamo passati da quella che chiamavamo la costruzione europea a quella che potremmo definire la decostruzione europea”, e ancora “ oggi l’Europa funziona come integrazione negativa, attraverso la Corte di Giustizia, che ha la capacità di continuare a smantellare i sistemi nazionali, ma è bloccata nella sua capacità di integrazione positiva … quindi oggi l’Europa, e le istituzioni europee, con questa svolta, sono diventate elementi di decostruzione dei diritti sociali nazionali”. Il grande giuslavorista francese sottolinea acutamente che “per un giurista è l’Europa la prima a rinunciare al concetto di territorio e a sostituire questo con quello di spazio” Il trattato costitutivo definisce infatti l’Europa come uno spazio di libertà e di giustizia, ma nel linguaggio giuridico tale termine – spazio – veniva usato solo per il mare e gli spazi intersiderali. Quindi un “universo senza forma dove soltanto i rapporti di forza potevano essere esercitati”.
Per recuperare anche il fortunato – forse fin troppo – vocabolo usato da Bauman, è in atto una gigantesca “liquidazione”. Ogni rigidità deve venire abbattuta, ogni confine reso valicabile anzi cancellato, quindi nella Ue “si parla di flessibilità e non di libertà, di employability (occupabilità) e non di capacità, di capitale umano e non di capacità professionale”. La liquidazione, nel doppio significato di eliminare e rendere liquido, avviene anche per le leggi che vengono considerate, sempre secondo Supiot, “prodotti in competizione sul mercato”. La Corte di Giustizia crea una sorta di “darwinismo normativo”, un vero mercato dei prodotti legislativi, in base al quale la Banca Mondiale, nel suo programma Doing Business, consultabile anche su Internet, stila una classifica delle legislazioni sociali dei vari paesi, ove il brutto voto viene attribuito a quelli dove permane un certo grado di “rigidità” normativa, ancora in grado di proteggere i diritti sociali. Ovviamente tutto ciò serve per indicare dove vanno indirizzati gli investimenti, nella fondata convinzione che laddove minimi sono i diritti maggiori possono essere i profitti. Più o meno alle stesse conclusioni giungeva Massimo Roccella, professore di diritto del lavoro all’Università di Torino, prematuramente scomparso, quando affermava che “Commissione europea e Corte di Giustizia si muovono in direzione di un mercato del lavoro sempre più liberalizzato, disarticolando le garanzie del modello sociale europeo” (10).
Le tre sentenze decostruttrici
Secondo Supiot la grande spinta verso la decostruzione è cominciata a cavallo del secolo, poiché per buona parte degli anni ’90 ancora si usava prudenza e attenzione verso il concetto di solidarietà, che veniva definito anche sul piano giuridico. Ma poi, soprattutto nel primo decennio degli anni duemila, alcune sentenze chiave hanno cambiato il quadro, quali la sentenza Viking (2007), la Laval (2007) e la Ruffert (2008). Per le prime due si tratta di sentenze diverse su casi simili riguardanti iniziative di aziende europee contro le quali i sindacati nazionali ed europei avevano intrapreso azioni per denunciare il rischio di dumping sociale.
La sentenza Laval è relativa a una società di costruzioni lettone che intendeva praticare in Svezia salari inferiori a quelli definiti dalla contrattazione collettiva di settore. Nel 2004, il sindacato svedese delle costruzioni blocca i cantieri della società lettone perché questa pagava salari inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, chiedendo alla Laval di sottoscrivere la convenzione svedese di settore. L’impresa lettone si rifiuta. I cantieri furono bloccati e il caso fu portato di fronte alla magistratura svedese che a sua volta chiese l’intervento della Corte di Giustizia europea. Quest’ultima ha dato un giudizio sfavorevole all’azione sindacale, considerandola «una restrizione alla libera circolazione dei servizi». Secondo la Corte, la legge del 1997 sul distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi obbligava il gruppo lettone a osservare una serie di regole imperative di protezione minima nello Stato di accoglienza, ma in Svezia la trasposizione di tale legge non prende in considerazione le retribuzioni poiché il loro livello è frutto di accordi tra partner sociali. La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ha espresso profonda delusione in merito a questa sentenza, dichiarandosi preoccupata «per le conseguenze che il caso potrebbe avere sul sistema svedese (e di altri Paesi) di convenzioni collettive». Inoltre, secondo la CES questa sentenza «potrebbe avere anche conseguenze circa la capacità dei sindacati a sostenere la parità di trattamento e la protezione dei lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità“.
La decisione della Corte europea giunse inaspettata per i sindacati europei, anche perché solo una settimana prima la stessa Corte aveva dato un giudizio diverso su un caso simile, pur lasciando qualche dubbio alla CES. Si trattava di un’azione intrapresa da una compagnia marittima finlandese, la Viking, che aveva cambiato bandiera a una nave di sua proprietà facendola diventare un’impresa lettone e applicando all’equipaggio della nave un diverso contratto collettivo. Decisione contro cui erano state organizzate azioni di protesta da sindacati di vari Paesi che miravano a ottenere l’annullamento dell’operazione e richiedevano che ai lavoratori si applicasse il contratto collettivo finlandese. La Corte di Giustizia aveva considerato legittima l’azione sindacale collettiva perrché finalizzata a proteggere i posti di lavoro e a migliorare le condizioni di lavoro, ribadendo il diritto allo sciopero e all’azione collettiva come fondamentale e riconosciuto dall’ordinamento comunitario. In quell’occasione, la CES aveva espresso soddisfazione per la sentenza, ma anche qualche preoccupazione sul rischio di limitare il campo d’applicazione e ostacolare l’esercizio di un’azione collettiva, in particolare per quanto riguarda le situazioni transfrontaliere. «Questa sentenza protegge chiaramente i sindacati a livello locale e nazionale rimettendo in causa la libertà di stabilimento delle imprese. E’ tuttavia meno chiara riguardo ai diritti sindacali transnazionali» aveva dichiarato il segretario generale della CES, John Monks, aggiungendo: «Avremmo voluto un riconoscimento più chiaro e senza ambiguità dei diritti dei sindacati a conservare e a difendere i diritti dei lavoratori e la parità di trattamento e a cooperare al di là delle frontiere per controbilanciare il potere, sempre più mondiale, delle imprese».
Diverso è il caso e l’oggetto della sentenza Ruffert, in base alla quale la Corte dichiarò che un Land tedesco non può imporre i propri salari minimi a lavoratori distaccati da società che provengono da paesi dell’Est. La sentenza Rűffert, quindi non fa riferimento tanto al diritto di sciopero o a quello alla contrattazione collettiva, seppure è evidente che essa non li valorizza. Qui viene rimessa in gioco la possibilità di istituire criteri minimi retributivi per vie non contrattuali, ma legislative, dal momento che si nega a queste ultime una possibilità applicativa generale entro un determinato territorio. Ovvero la legge dell’impresa sopravanza e mortifica quella dello Stato.
La nuova governance europea
D’altro canto le politiche deflattive e rigoriste che impongono tagli di bilancio in nome della riduzione a tappe forzate del debito pubblico accumulato (in buona parte per fare fronte al pericolo di fallimento delle banche durante l’attuale crisi) come è contenuto nel famoso fiscal compact (di cui abbiamo abbondantemente parlato in numeri precedenti di questa rivista), costituiscono una dura barriera alla possibilità della ripresa dell’attività sindacale sul terreno direttamente sociale. Esemplare a questo riguardo è la vicenda del Piano del lavoro elaborato dalla Cgil. Lo si dovrebbe discutere nei dettagli – cosa impossibile a farsi nell’ambito di questo articolo – ma una cosa salta subito agli occhi. Per quanto apprezzabile sia stato lo sforzo dei dirigenti sindacali e degli studiosi impegnati nell’impresa, risulta ben difficile pensare che un simile progetto possa avere qualche pur parziale possibilità di realizzazione in un quadro segnato dall’accettazione da parte di quasi tutte le forze politiche, in particolare quelle che presumibilmente andranno al governo, dei vincoli del fiscal compact, che prevede la riduzione del 3% del bilancio per i prossimi venti anni, aggravata dalla introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione con effetto a partire dall’anno in corso.
Ma non si tratta solo di questo. Il Consiglio europeo che si sta aprendo mentre concludo questo articolo si concentra sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Come si sa il bilancio attuale della Ue ha proporzioni ridicole: si tratta solo dell’1% annuo del Pil complessivo della Ue. Ma tale bilancio ha già subito una decurtazione: dagli iniziali 1091 miliardi di euro si è scesi, dopo il Consiglio europeo di novembre a 972. Ma ciò che più conta è che i tagli hanno colpito soprattutto i settori più innovativi e dinamici dell’economia europea, quindi quelli dove potenzialmente è più probabile creare occupazione. Come non bastasse il presidente del consiglio europeo sta trattando un ulteriore decurtazione, così come vorrebbero gli inglesi in particolare, ma anche i tedeschi e non solo. Il Parlamento europeo, con il suo presidente, Martin Schulz, è invece contrario, perché l’ipotesi Van Rompuy porterebbe il bilancio della Ue nel 2020 allo stesso livello in cui era nel 2005. Varrà la pena di seguire questo scontro, poiché in questa materia il Parlamento europeo ha potere di veto. Ma è già chiaro che la crisi della globalizzazione si esprime anche con il tentativo di una sorta di rinazionalizzazione delle politiche di bilancio, che può solo favorire i paesi più forti, mentre da un incremento del bilancio europeo e del miglioramento della sua qualità di spesa può venire un impulso notevole al un nuovo tipo di crescita in particolare nei paesi mediterranei come il nostro.
Per una nuova coalizione del lavoro
Per tutte queste ragioni, la crisi del sindacato non si risolve se contemporaneamente esso non assume una dimensione di lotta europea sui temi salariali e normativi della condizione lavorativa, se non contesta il carattere monocratico dell’impresa e le sue scelte produttive e se, necessariamente al contempo, non concorre a modificare le linee di fondo delle politiche economiche europee capovolgendo il principio ossimorico della “austerità espansiva”.
La rinascita di un movimento sindacale europeo passa necessariamente per vie conflittuali con gli attuali assetti di potere economico ai diversi livelli. Anche la conquista di spazi partecipativi nell’indirizzo delle scelte produttive dell’impresa sui modelli del nord Europa, che come abbiamo detto conoscono anch’essi un periodo di crisi, non può prescindere dall’apertura di una nuova fase di conflittualità, sia nei paesi dove la partecipazione già era in atto, sia in quelli dove essa è stata da sempre assente, anche per responsabilità e per deficit culturali delle stesse organizzazioni sindacali, come nel caso italiano, ove lo stesso dettato costituzionale in materia è rimasto del tutto disatteso. Tuttavia è decisivo, per la costruzione di una nuova coalizione del lavoro, aggredire la contraddizione fra la volatilità del capitale e la stanzialità del lavoro. La dimensione territoriale nella quale inevitabilmente vive e si organizza il lavoro deve cioè diventare la base di partenza per occupare lo spazio europeo, e non per rinchiudersi in essa, sia in senso proprio, geografico, che in senso figurato, sociale.
Ovvero bisogna che sia a livello categoriale che intercategoriale si trovi un collegamento, un’unità di pensiero e di azione, capace di legare assieme le varie realtà dell’impresa diffusa nello spazio internazionale. I grandi settori, quali quelli maturi dell’auto, come quelli più innovativi delle telecomunicazioni o dell’energia, che investono temi non solo squisitamente sindacali, ma di indirizzo della politica economica a livello europeo, possono fare da traino e da esperienza guida in questa direzione. Occorre pensare a una politica di convergenza dei salari europei, per eliminare le profonde diseguaglianze, i pericoli di dumping sociale e la formazione di aristocrazie operaie contrapposte al resto del mondo del lavoro nel continente, di cui si vedono già inquietanti tratti nel caso tedesco.
Nello stesso tempo l’organizzazione sindacale deve conquistare una propria “spazialità sociale”, ovvero puntare alla rappresentanza e all’organizzazione di tutti i frammenti del mondo del lavoro, di tutte le forme di precariato, dei migranti e dei lavoratori de localizzati. Compito complesso e arduo, come ben si vede. Ma il livello cui è giunta la crisi del sindacato in Europa non può essere risolta semplicemente strattonando la Confederazione europea dei sindacati (Ces), per risvegliarla dal suo sonno profondo. Si deve per forza pensare, anche se attraverso passaggi graduali ma sostanziosi, a un vero processo rifondativo. Come sempre la chiave di volta per intraprenderlo è introdurre forme di democrazia sindacale, permettendo in sostanza alle lavoratrici e ai lavoratori di votare e decidere su tutto ciò che li riguarda, in primo luogo sui contratti che vengono stipulati a ogni livello.
di Alfonso Gianni
________________________________________________________________________
Note
1.Horst Kern, Michael Schumann La fine della divisione del lavoro? Produzione industriale e razionalizzazione, Einaudi, Torino, 1991
2. Horst Kern, Michael Schumann Industriearbeit und Arbeiterdbewustsein…, Frankfurt am Main, 1970, poi Suhrkamp, Frankfurt am Main,1977, 1980
3.Robert Blauner, Alienazione e libertà, Milano, 1971
4.Francesco Garibaldo, “The social roots of the democratic crisis of the EU and the role of Trade Unions” in Francesco Garibaldo, Volker Telljohannn The Ambivalent Character of Partecipation: new tendencies in worker participation in Europe, Peter Lang, 2010
5.Karl Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro Terzo. Pag. 533, Einuadi, Torino 1975
6.Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003
7.Citato in Antonio Baylos Grau, “Finestre sulla crisi. Crisi, modello europeo e riforma del lavoro” in Lavoro e Diritto a. XXIV, n. 3, estate 2010
8.Citato in Ibidem
9.Alain Supiot, Fermare la decostruzione dell’Europa, in Insight, http://www.insightweb.it/web/node/80, 2009
10.Massimo Roccella, L’Unione europea tra liberismo e dumping sociale, in Insight, http://www.insightweb.it/web/node/110, 2009