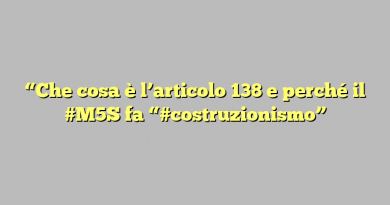I comportamenti denigratori e vessatori del «capo» sul luogo di lavoro nei confronti dei dipendenti integrano il reato di violenza privata
Non si configura il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì quello di violenza privata, a carico del titolare di una piccola impresa che sottopone il dipendente a sistematiche vessazioni e offese. Così ha statuito la sesta sezione della Cassazione penale nella sentenza n. 12517 del 3 aprile 2012.
Nella fattispecie concreta gli atti vessatori continuativi, rappresentati da insulti, offese e ripetute aggressioni verbali, sono stati posti in essere nell’ambito di un’azienda di dimensioni ridotte, caratterizzata dalla quotidiana presenza dei datori di lavoro e dall’esercizio diretto, da parte loro, dei poteri di supremazia nei confronti dei dipendenti, senza l’ausilio di alcun intermediario. Per la Corte, tuttavia, le ridotte dimensioni dell’azienda e l’impegno lavorativo diretto in essa da parte dei titolari non sono condizioni sufficienti a delineare quel contesto di «comunità familiare» richiesto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli). In ordine alla possibile applicazione della disciplina dettata da tale norma anche all’ambito lavorativo esiste un lungo filone della giurisprudenza di legittimità che ha più volte sottolineato come, oltre al mero rapporto di sovraordinazione, sia a tal fine necessario che il rapporto di lavoro si svolga con forme e modalità tali da
assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura «para-familiare». In questa direzione si è giunti ad indicare come esempio di rapporto di lavoro cui sarebbe applicabile la disciplina dell’art. 572 c.p. quelli «tipicamente a carattere familiare», o «caratterizzati da familiarità», come il rapporto tra colf e persone della famiglia e quello non occasionale tra maestro d’arte e apprendista.
In definitiva, se l’ambito delle condotte idonee a configurare il delitto di maltrattamenti risulta allargato anche oltre quello esclusivamente endo-familiare, tuttavia è vero che la fattispecie incriminatrice rimane inserita nell’ambito del Titolo dedicato ai «Delitti contro la famiglia» e circoscrive nella rubrica il disvalore della condotta illecita, la quale risulta penalmente rilevante se tenuta nella famiglia o verso i fanciulli. Non può, pertanto, ritenersi idoneo ad integrare gli estremi dell’illecito in questione il mero contesto di generico e generale rapporto di subordinazione/sovra ordinazione. Di qui la necessità, stigmatizzata dai giudici di legittimità, del presupposto della «para-familiarità» del rapporto di sovraordinazione, che si caratterizza per la sottoposizione di una persona all’autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo l’esercizio dell’autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità.
A ritenere diversamente, la Corte sottolinea il rischio di dover configurare ogni relazione lavorativa caratterizzata da ridotte dimensioni e dal diretto impegno del datore di lavoro alla stregua di una comunità para-familiare, idonea ad imporre la qualificazione in termini di violazione dell’art. 572 c.p. di condotte che, di eguale contenuto ma poste in essere in un contesto più ampio, avrebbero solo rilevanza in ambito civile (es. mobbing), con evidente irragionevolezza del sistema.
Tanto premesso, gli Ermellini concludono nel senso che il rapporto di sovraordinazione tra datore di lavoro e dipendente, le dimensioni ridotte dell’impresa e l’impegno lavorativo personale del datore di lavoro costituiscono elementi circostanziali necessari ma non sufficienti ad integrare quel contesto «para-familiare» che, solo, giustifica l’applicazione dell’art. 572 c.p. ai rapporti di lavoro subordinati. Detti elementi, accompagnati dalla reiterazione di una condotta offensiva, denigratoria ed aggressiva, realizzano piuttosto gli estremi per qualificare la fattispecie in termini di «violenza privata».
Anna Costagliola