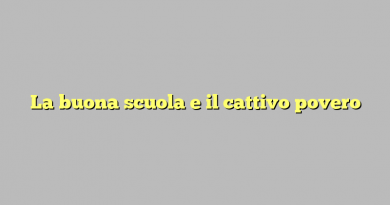Il ritorno della lotta di classe. (Paolo Ercolani intervista Domenico Losurdo)
Professor Losurdo, ci spieghi questa idea di un libro sulla lotta di classe, concetto che da molte parti era stato dato per morto.
Mentre la crisi economica infuria, si infittiscono i saggi che evocano il «ritorno della lotta di classe». Era dileguata? In realtà, gli intellettuali e i politici che proclamavano il tramonto della teoria marxiana della lotta di classe commettevano un duplice errore. Per un verso abbellivano la realtà del capitalismo. Negli anni ’50 Ralf Dahrendorf affermava che si stava verificando un «livellamento delle differenze sociali» e che quelle stesse modeste «differenze» erano solo il risultato del merito scolastico; sennonché, bastava leggere la stampa statunitense anche la più allineata, per rendersi conto che anche nel paese-guida dell’Occidente sussistevano sacche paurose di una miseria che si trasmetteva ereditariamente da una generazione all’altra. Ancora più grave era il secondo errore, quello di carattere più propriamente teorico. Erano gli anni in cui si sviluppava la rivoluzione anticoloniale in Vietnam, a Cuba, nel Terzo Mondo; negli USA i neri lottavano per porre fine alla white supremacy, al sistema di segregazione, discriminazione e oppressione razziale che ancora pesava su di loro. I teorici del superamento della lotta di classe erano ciechi dinanzi alle aspre lotte di classe che si svolgevano sotto i loro occhi.
Se non capiamo male, quindi, lei amplia oltremodo il campo semantico dell’espressione «lotta di classe, comprendendo al suo interno una gamma di problemi e questioni molto più ampia?
Sì, Marx ed Engels richiamano l’attenzione non solo sullo sfruttamento che ha luogo nell’ambito di un singolo paese, ma anche sullo «sfruttamento di una nazione da parte di un’altra». Anche in questo secondo caso abbiamo a che fare con una lotta di classe. In Irlanda, dove i contadini erano sistematicamente espropriati dai coloni inglesi, la «questione sociale» assumeva la forma di «questione nazionale», e la lotta di liberazione nazionale del popolo irlandese non solo era una lotta di classe, ma una lotta di classe particolare rilievo: è nelle colonie infatti – osserva Marx – che «l’intrinseca barbarie della civiltà borghese» si rivela nella sua nudità e in tutta la sua ripugnanza.
Ci può spiegare meglio la genesi storico-filosofica di questa sua lettura così desueta rispetto alle categorie tradizionali?
La cultura dell’Ottocento era chiamata a rispondere a tre sfide teoriche. In primo luogo, in che modo spiegare la marcia irresistibile dell’Occidente, che col suo espansionismo coloniale assoggettava l’intero pianeta, travolgendo anche paesi di antichissima civiltà come la Cina? Mentre conseguiva il trionfo sul piano internazionale, l’Occidente si vedeva minacciato al suo interno dalla rivolta di masse popolari che per la prima volta irrompevano, e in modo rovinoso, sulla scena della storia. Ebbene, quali erano le cause di questo fenomeno inaudito e angosciante? In terzo luogo l’Occidente presentava un quadro assai differenziato da paese a paese. Se in Inghilterra e negli Stati Uniti si assisteva a uno sviluppo graduale e pacifico all’insegna di una libertà ben ordinata, del tutto diverso era il caso della Francia: qui alla rivoluzione faceva seguito la controrivoluzione, spazzata a sua volta da una nuova rivoluzione; a partire dal 1789, i regimi politici più diversi (monarchia assoluta, monarchia costituzionale, terrore giacobino, dittatura militare napoleonica, Impero, repubblica democratica, bonapartismo) si susseguivano l’uno all’altro, senza che mai si realizzasse la libertà ordinata. Ebbene, qual era la maledizione che pesava sulla Francia? A tutte tre queste sfide teoriche la cultura dominante dell’Ottocento rispondeva rinviando in modo più o netto alla «natura». Per dirla con Disraeli, la razza è «la chiave della storia» e «tutto è razza e non c'è altra verità» e a definire una razza «è solo una cosa, il sangue»; e questa era anche l’opinione di Gobineau. Si spiegavano così il trionfo dell’Occidente ovvero della superiore razza bianca e ariana, la rivolta di quei «barbari» e «selvaggi» che erano gli operai, le convulsioni incessanti di un paese come la Francia devastato dal miscuglio razziale. Altre volte, la natura a cui si rinviava aveva un significato più blando. Per Tocqueville non c’erano dubbi: il trionfo della «razza europea» su «tutte le altre razze» era voluto dalla Provvidenza; il più ordinato svolgimento di Inghilterra e Stati e Uniti era la prova del più robusto senso morale e senso pratico degli anglosassoni rispetto ai francesi, i quali ultimi erano devastati dalla follia rivoluzionaria ovvero da un «virus di una specie nuova e sconosciuta». Come si vede, il paradigma razziale in senso stretto (caro a Gobineau e Disraeli) tendeva a essere sostituito dal paradigma etnologico-razziale e da quello psicopatologico. Restava fermo il rinvio a una «natura» più o meno immaginaria e l’abbandono del terreno della storia.
È sull’onda della lotta contro questa visione che Marx ed Engels elaboravano la teoria della lotta di classe. La marcia trionfale dell’Occidente non si spiegava né con la gerarchia razziale né con i disegni della Provvidenza; essa esprimeva l’espansionismo della borghesia industriale e la sua tendenza a costruire il «mercato mondiale» travolgendo e sfruttando i popoli e i paesi più deboli e più arretrati. I protagonisti delle rivolte popolari in Occidente non erano né barbari né folli; erano piuttosto i proletari che, in seguito allo sviluppo industriale, diventavano sempre più numerosi e acquisivano una più matura coscienza di classe. In un paese come gli Stati Uniti il conflitto sociale borghesia/proletariato era meno acuto, ma solo perché l’espropriazione e la deportazione dei nativi consentiva di trasformare in proprietari terrieri una parte consistente di proletari, mentre la schiavizzazione dei neri rendeva possibile il ferreo controllo delle «classi pericolose». Ma tutto ciò non aveva nulla a che fare con un superiore senso morale e pratico degli americani, com’era confermato dalla sanguinosissima guerra civile, che nel 1861-65 vedeva scontrarsi la borghesia industriale del Nord contro l’aristocrazia terriera e schiavistica del Sud e, nell’ultima fase del conflitto, gli schiavi (arruolatisi nell’esercito dell’Unione) contro i loro padroni o ex-padroni.
Per comprendere lo svolgimento storico occorre rinviare alla storia e alla lotta di classe, anzi alle «lotte di classe» che assumono forme molteplici e variegate, si intrecciano l’una all’altra in modo peculiare e conferiscono una configurazione sempre diversa alle diverse situazioni storiche.
Il suo discorso sembra, quindi, partire anzitutto da una lettura nuova del lascito di Marx ed Engels?
La mia lettura di Marx ed Engels può stupire ma rileggiamo il Manifesto del partito comunista: «La storia di ogni società sinora esistita è la storia delle lotte di classe», e queste assumono «forme diverse». Il ricorso al plurale fa intendere che quella tra proletariato e borghesia o tra lavoro dipendente e classi proprietarie è solo una delle lotte di classe. C’è anche la lotta di classe di una nazione che si scuote di dosso lo sfruttamento e l’oppressione coloniale. Non bisogna infine dimenticare un punto su cui Engels insiste in modo particolare: «la prima oppressione di classe coincide con quella del sesso femminile da parte di quello maschile»; nell’ambito della famiglia tradizionale «la donna rappresenta il proletariato» Siamo dunque in presenza di tre grandi lotte di classe: gli sfruttati e gli oppressi sono chiamati a modificare radicalmente la divisione del lavoro e i rapporti di sfruttamento e di oppressione che sussistono a livello internazionale, in un singolo paese e nell’ambito della famiglia.
Un discorso che porta lontano, ma che anzitutto può aiutare a leggere il passato con un’ottica nuova.
Solo così possiamo comprendere il secolo alle nostre spalle. Ai giorni nostri, uno storico di grande successo, Niall Ferguson, scrive che nella grande crisi storica della prima metà del Novecento, la «lotta di classe», anzi le «presunte ostilità tra proletariato e borghesia» hanno svolto un ruolo ben modesto; ben più rilevanti sarebbero state «le divisioni etniche». Sennonché, argomentando in tal modo, si rimane fermi al punto di vista del nazismo che leggeva la guerra a Est come una «grande guerra razziale». Ma quali erano gli obiettivi reali di tale? Espliciti sono i Discorsi segreti di Heinrich Himmler: «Se non colmiamo i nostri campi di lavoro di schiavi – in questa stanza posso definire le cose in modo netto e chiaro – di operai-schiavi che costruiscano le nostre città, i nostri villaggi, le nostre fattorie, senza riguardo alle perdite», il programma di colonizzazione e germanizzazione dei territori conquistati in Europa orientale non potrà essere realizzato. La lotta di un intero popolo o di interi popoli per evitare il destino di schiavi cui vorrebbe consegnarlo una presunta razza di signori e di padroni è chiaramente una lotta di classe!
Una vicenda analoga si svolge in Asia, dove l’Impero del Sol Levante imita il Terzo Reich e riprende e radicalizza la tradizione coloniale. La lotta di classe di interi popoli che lottano per sfuggire alla schiavizzazione trova il suo interprete in Mao Zedong, che nel novembre del 1938 sottolinea l’«identità fra la lotta nazionale e la lotta di classe» che si è venuta a creare nei paesi investiti dall’imperialismo giapponese. Come nell’Irlanda di cui parla Marx la «questione sociale» si presenta concretamente come «questione nazionale», così nella Cina del tempo la forma concreta assunta dalla «lotta di classe» è la «lotta nazionale».
La sua è un’interpretazione oltremodo eterodossa, che potrebbe attirare su di lei, come peraltro è avvenuto spesso, in passato, le critiche accese anche della sinistra, oltre a quelle del mondo liberale.
Disgraziatamente anche nella sinistra “radicale” è diffusa la visione per cui la lotta di classe rinvierebbe esclusivamente al conflitto tra proletariato e borghesia, tra lavoro dipendente e classi proprietarie. Si fa avvertire in modo negativo l’influenza di un’eminente filosofa, Simone Weil, secondo cui la lotta di classe sarebbe «la lotta di coloro che obbediscono contro coloro che comandano». Non è questo il punto di vista di Marx ed Engels. In primo luogo, ai loro occhi, è lotta di classe anche quella condotta da coloro che sfruttano e opprimono. Anche a volersi concentrare sulla lotta di classe emancipatrice, essa può ben essere condotta dall’alto, da «coloro che comandano». Si prenda la Guerra di secessione negli USA. Sul campo di battaglia si fronteggiavano non i potenti e gli umili, i ricchi e i poveri, bensì due eserciti regolari. E, tuttavia, sin dagli inizi, Marx additava nel Sud il campione dichiarato della causa del lavoro schiavistico e nel Nord il campione più o meno consapevole della causa del lavoro «libero». In modo del tutto inaspettato, la lotta di classe per l’emancipazione del lavoro prendeva corpo in un esercito regolare, disciplinato e potentemente armato. Nel 1867, pubblicando il primo libro del Capitale, Marx indicava nella Guerra di secessione «l’unico avvenimento grandioso della storia dei giorni nostri», con una formulazione che richiama alla memoria la definizione della rivolta operaia del giugno 1848 come «l’avvenimento più colossale nella storia delle guerre civili europee». La lotta di classe, la stessa lotta di classe emancipatrice, può assumere le forme più diverse.
Dopo la rivoluzione d’ottobre Lenin sottolinea ripetutamente: «La lotta di classe continua; ha soltanto cambiato le sue forme». L’impegno a sviluppare le forze produttive, migliorando le condizioni di vita delle masse popolari, ampliando la base sociale di consenso del potere sovietico e rafforzando la sua capacità di attrazione sul proletariato occidentale e sui popoli coloniali, tutto ciò costituiva la forma nuova assunta nella Russia sovietica dalla lotta di classe.
Come spiegare questo impressionante fraintendimento della teoria della lotta di classe proprio di una parte, la sinistra, che sulla teoria del conflitto sociale ha costruito buona parte della propria azione storica?
La sinistra anche radicale fa fatica a comprendere la teoria della lotta di classe in Marx ed Engels perché è influenzata dal populismo. Il populismo si presenta qui in due forme tra loro connesse. La prima abbiamo già cominciato a vederla: è la trasfigurazione dei poveri, degli umili, visti come gli unici depositari degli autentici valori morali e spirituali e gli unici possibili protagonisti di una lotta di classe realmente emancipatrice. È una visione di cui si fa beffe già il Manifesto del partito comunista, che critica l’«ascetismo universale» e il «rozzo egualitarismo» e aggiunge: «nulla di più facile che dare all’ascetismo cristiano una mano di vernice socialista». Secondo Marx ed Engels questa visione caratterizza i «primi moti del proletariato». In realtà, questa prima forma di populismo sì è manifestata con forza nella Russia sovietica, allorché molti operai, anche iscritti al partito bolscevico, hanno condannato la NEP come un tradimento degli ideali socialisti. Una replica di tali processi e conflitti si è manifestata in Cina allorché, in polemica contro la trasfigurazione del pauperismo e della visione del socialismo quale distribuzione «egualitaria» della miseria, Deng Xiaoping ha chiamato a realizzare la «comune prosperità» da conseguire tappa dopo tappa (e sia pure attraverso molteplici contraddizioni). È in questo quadro che va collocato lo slogan «Diventare ricchi è glorioso!», che ha suscitato tanto scandalo anche nella sinistra occidentale.
La seconda forma di populismo trova la sua espressione più eloquente, e più ingenua, di nuovo in Simone Weil allorché negli anni ’30 immagina uno scontro omogeneo sul piano planetario e risolutore una volta per sempre: a fronteggiarsi sarebbe «l’insieme dei padroni contro l’insieme degli operai»; si tratterebbe una «guerra condotta dall’insieme degli apparati di Stato e degli stati maggiori contro l’insieme degli uomini validi e in età di imbracciare le armi», di una guerra che vede scontrarsi l’insieme dei generali contro l’insieme dei soldati! In questa prospettiva non c’è più il problema dell’analisi delle forme di lotta di classe di volta in volta diverse nelle diverse situazioni nazionali e nei diversi sistemi sociali. Dappertutto è all’opera un’unica contraddizione allo stato puro: quella che contrappone ricchi e poveri, potenti e umili.
È evidente l’influenza che questa seconda forma di populismo continua a svolgere ancora ai giorni nostri in particolare sulla sinistra occidentale: quando nel fortunatissimo libro di Hardt e Negri, Impero, leggiamo la tesi secondo cui nel mondo di oggi a una borghesia sostanzialmente unificata a livello planetario si contrapporrebbe una «moltitudine» essa stessa unificata dal dileguare delle barriere statali e nazionali, quando leggiamo ciò non possiamo non pensare alla visione cara a Simone Weil.
Questa sua impegnativa ricostruzione del problema fornisce una chiave di lettura anche per l’oggi?
Certamente! Sono tuttora all’opera le tre forme fondamentali di lotta di classe analizzate da Marx ed Engels. Nei paesi capitalistici avanzati la crisi economica, la polarizzazione sociale, la crescente disoccupazione e precarizzazione, lo smantellamento dello Stato sociale, tutto ciò acutizza il conflitto tra lavoro dipendente e una élite privilegiata sempre più ristretta. È una situazione che compromette alcune delle conquiste sociali delle donne, la cui lotta di emancipazione risulta però particolarmente difficile in paesi che non hanno ancora raggiunto lo stadio della modernità. Per quanto riguarda il Terzo Mondo, la lotta di classe continua ancora a manifestarsi in misura considerevole quale lotta nazionale. Ciò è immediatamente evidente per il popolo palestinese, i cui diritti nazionali sono calpestati dall’occupazione militare e dagli insediamenti coloniali. Ma la dimensione nazionale della lotta di classe non è dileguata neppure nei paesi che si sono liberati dall’assoggettamento coloniale. Essi sono chiamati a lottare non contro uno bensì contro due tipi diseguaglianza: per un verso devono ridurre le disparità sociali al loro interno; per un altro verso devono colmare o attenuare il distacco che li separa dai paesi più avanzati. I paesi che, soprattutto in Africa, hanno trascurato questo secondo compito e che non hanno compreso la necessità di passare a un certo momento dalla fase militare a quella economica della rivoluzione anticoloniale, tali paesi non hanno alcuna reale indipendenza economica e sono esposti all’aggressione o alla destabilizzazione promossa o favorita dall’esterno.
Abbiamo dunque tre forme di lotta di classe emancipatrice, tra le quali non c’è armonia prestabilita: come combinarle nelle diverse situazioni nazionali e a livello internazionale in modo che possano confluire in unico processo di emancipazione, è questa la sfida con cui deve misurarsi una sinistra autentica.
Domenico Losurdo è uno degli studiosi di filosofia italiani più tradotti al mondo. Tutti i suoi libri hanno visto, infatti, edizioni in inglese, americano, tedesco, francese, spagnolo, ma anche portoghese, cinese, giapponese, greco. Qualche lingua la dimentichiamo sicuramente. Il Financial Times e la Frankfurter Allgmeine Zeitung, fra gli altri, gli hanno dedicato pagine intere. Un trattamento che stride oltremodo con quello che gli viene riservato in patria, dove spesso e volentieri i suoi lavori sono fatti oggetto di un silenzio studiato. Che pur tuttavia non incide sulle vendite, viste le reiterate edizioni dei suoi libri.
In questi giorni sta dando alle stampe, per i tipi di Laterza, la sua nuova fatica intitolata La lotta di classe? Una storia politica e filosofica (388 pagine), e per questo Critica liberale lo è andato a intervistare nella sua casa/biblioteca sulle colline intorno a Urbino.