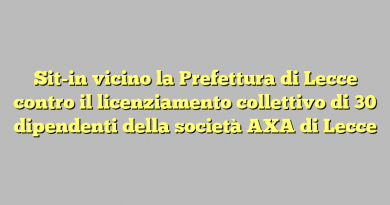“Siamo un pò più uguali ai movimenti globali”
So ben poco, oltre a quanto ciascuno di noi può desumere da foto, filmati, reportage e commenti pubblicati da giornali e internet in questi giorni, o da qualche incontro fortuito, sul movimento “Fermiamo l’Italia” ovvero “9 dicembre”; ma non mi sento per questo in una condizione molto diversa da altri commentatori, perché tutti sono (siamo) stati presi alla sprovvista.
Questa è una rivolta, covata, ma anche preparata e cresciuta per più di un anno, fuori dal cono di luce dei media. Quanto scrivo non ha quindi la pretesa di un’analisi di questo movimento. E’ solo un modesto tentativo di aprire una discussione con qualche lettore di un’area politica e culturale a cui di fatto appartengo, anche se ne condivido sempre meno perimetro e impostazioni.
Innanzitutto, non chiamiamoli “Forconi”. Forconi è il simbolo delle jacqueries di un tempo – un arnese peraltro un po’ attempato, come lo sono la falce e il martello – ovvero la sigla di una delle componenti di questo movimento. La maggior parte dei coloro che partecipano al movimento l’hanno chiamato – e non a caso — “Fermiamo l’Italia” o “9 dicembre”. Rispettiamone la volontà.
Per mesi si è svolto su riviste e blog di sinistra un dibattito sul perché in Italia non ci siano stati movimenti di piazza analoghi a quelli di Grecia, Spagna o Stati uniti, nonostante il nostro paese sia uno tra i più colpiti dalla crisi, dall’economia del debito e dal malgoverno. La risposta più intelligente e completa – ma non per questo la più convincente – è stata quella del collettivo WuMing: il movimento Cinque stelle avrebbe di fatto assorbito e incanalato una tensione prevenendone l’esplosione in piazza.
Adesso eccolo quel movimento! In forme completamente diverse da quelle che chiunque – e in particolare la cultura della sinistra e il movimento dei comitati, dei centri sociali e delle associazioni; ma in gran parte anche il movimento Cinque stelle – se lo sarebbe potuto o voluto aspettare. Ma prodotto incontestabile della crisi, dei debiti e del malgoverno. Non è e non sarà la sola manifestazione di rivolta contro questo stato di cose. Quella rivolta l’abbiamo già vista, in forme più ordinate e produttive, in Val di Susa (là dove le “larghe intese” sono state progettate e sperimentate per imporre il Tav, uno dei più devastanti prodotti a cui è approdata quella cultura della crescita senza obiettivi che impronta di sé tutto il pensiero unico); oppure tra i lavoratori e i cittadini liberi e pensanti di Taranto; o, in forme più conformi a una visione consolidata del conflitto di classe, tra di dipendenti dell’Atm di Genova. Ne vedremo altre nei prossimi mesi, compresa l’evoluzione che assumerà quella di questi giorni, e in forme che non mancheranno di sorprenderci e — perché no? — di spaventarci. Il conflitto di classe, diceva un tale a proposito della rivoluzione, che qui non è all’ordine del giorno, «non è un pranzo di gala».
Cinquant’anni fa, nel 1962, e proprio a Torino, una rivolta di piazza innescata da una manifestazione indetta dalla Cgil contro la Uil, (firmataria di un accordo separato con la Fiat per bloccare la lotta operaia in una fabbrica che era stata per più di un decennio teatro della più spietata oppressione padronale) era “degenerata” in quelli che sono passati alla storia come i fatti di Piazza Statuto. Sorprendendo tutti, perché nessuno se li aspettava; anche perché ai primi manifestanti si era aggiunta, tenendo la piazza per alcuni giorni, una folla sterminata di attori di incerta classificazione sociale: non la classe operaia inquadrata da sindacati e partiti, ma una folla anonima di operai di piccole e piccolissime fabbriche, di immigrati e disoccupati, di gente “senza arte né parte”: subito tacciati come “provocatori” dal Pci, che pure avrebbe poi dovuto contare tra gli arrestati anche diversi suoi membri e persino un funzionario. Eppure, a distanza di anni, gli storici concordano nel vedere in quei moti la scintilla di un risveglio e la manifestazione di una nuova composizione sociale che di lì a qualche anno sarebbero stati protagonisti dell’autunno caldo del ‘69 e delle lotte sociali del ’68 e degli anni Settanta.
Quello che si può dire oggi di questi manifestanti che si dichiarano “popolo” e che si riconoscono nella bandiera tricolore è che — al di là dell’indignazione che li accomuna alle manifestazioni di Grecia, Spagna e Stati uniti, ma anche di Turchia e Brasile, e prima ancora, di Tunisia ed Egitto, e che in Italia non si erano ancora viste — è che a venire in primo piano è la loro identità di poveri o di impoveriti: la manifestazione nuova e dilagante — ma trattata finora dai media solo con numeri e percentuali – di persone che non ce la fanno più. E non solo perché sono esasperati (in una maniera o nell’altra, lo siamo tutti o quasi); ma proprio perché non sanno più come campare: non hanno più lavoro né impresa (ambulanti, autotrasportatori e agricoltori sono il cuore della rivolta); né reddito, né possibilità di studiare, né pensioni sufficienti, né casa; né, soprattutto, possibilità di intravedere un qualsiasi futuro diverso dal protrarsi all’infinito di questa loro condizione. Sono il prodotto maturo della finanziarizzazione e della globalizzazione dell’economia, di quei poteri che hanno fatto terra bruciata di tutto quanto ancora esisteva tra la loro nuda vita e il potere di Stati, istituzioni e capitale; il segno più tangibile del fatto che «così non si può più andare avanti». Sono l’avanguardia che lo grida e che lo fa capire a tutti.
Ha indignato molta stampa benpensante – soprattutto di centro-sinistra – la chiusura forzata, per lo più senza episodi di violenza, imposta dai manifestanti a negozi e pubblici esercizi. Ma per chi il conflitto lo deve fare in piazza perché non ha o non ha più un luogo di lavoro da cui far sentire le sue richieste, quella è una forma di lotta. Come un picchetto operaio: quello che alcuni chiamano un’arbitraria limitazione alla libertà di lavorare; ma vai poi a vedere che cosa succede di quella libertà in una ordinaria giornata lavorativa, una volta che i cancelli della fabbrica si sono rinchiusi. L’Ilva non ha insegnato niente?
Scandalo e soprattutto timore anche perché i poliziotti si sono levati i caschi e hanno deposto gli scudi di fronte ai manifestanti contro cui si erano scontrati fino a pochi minuti prima. Non è forse un atto di solidarietà nei loro confronti, preludio – dio non voglia! – a una diserzione dai loro compiti? Sì; è un atto di solidarietà e di fratellanza, checché ne dicano i sindacati di polizia, anche se probabilmente suggerito — o imposto e concordato con le organizzazioni fasciste che partecipano alle manifestazioni — dai superiori o dagli alti comandi delle “forze dell’ordine”. Proprio quei comandanti a cui si rivolge a Grillo, perché per lui la solidarietà non può nascere da un atto di ribellione, ma solo dall’obbedienza a un ordine; mentre andrebbe invece colta l’occasione per dire a quei tutori dell’ordine pubblico: «la solidarietà che avete manifestato a Torino e a Genova, la prossima volta datela anche ai NoTav della Valle di Susa. Ne vale la pena».
La rivolta del 9 dicembre non andrà avanti a tempo indeterminato, ma nemmeno si dissolverà come neve al sole. Dopo le giornate della mobilitazione sopraggiungerà il tempo del ripiegamento e della riflessione. E’ quello in cui potrà diventare possibile avvicinarsi ai suoi protagonisti non solo con una presenza in piazza, ma anche e soprattutto attraverso un confronto e uno sforzo condiviso per enucleare obiettivi e rivendicazioni comuni.
Le forme assunte da questa mobilitazione, che non è spontanea ma neanche frutto di una precisa organizzazione, ci possono far capire quanto distino le forme reali della partecipazione dalle forme strutturate della democrazia: quella rappresentativa dei Parlamenti e dei consigli comunali o regionali, ma anche quella partecipativa, di una gestione condivisa ben organizzata di rivendicazioni o di “beni comuni”. Non che vadano messe in contrapposizione; ma certo avvicinarle non è un processo né automatico né facile.
Altrettanto significativa è la dissoluzione, in questo ambito, delle tradizionali contrapposizioni tra destra e sinistra. Non che ciò debba significare mischiarsi e confondersi con le organizzazioni fasciste che a questi moti, o alla loro preparazione, hanno preso parte. Quelle organizzazioni sono radicate anche, e ben di più, nelle destre fasciste e naziste più tradizionali, con cui nessuna commistione è possibile. Ma per la maggioranza di coloro che partecipano a questi moti destra e sinistra, come pure politica, se non nell’accezione più pura di autogoverno, non hanno più alcun significato. Contano le distinzioni tra alto e basso, onesto e ladro, povero e ricco, sfruttato e sfruttatore. Impariamo a riusarle.
Da Il Manifesto
Guido Viale